| LA
CHIESA DI SAN FERMO |
 |
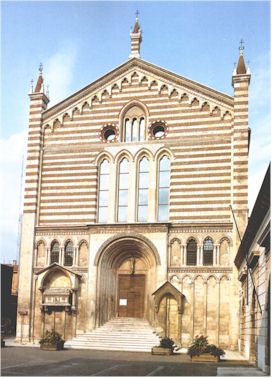 |
|
| |
| Una
chiesa dedicata a Fermo e Rustico, che avrebbero subito il martirio
a Verona all'inizio del IV secolo, esisteva già nell'VIII secolo,
quando il vescovo Annone vi fece riporre le reliquie dei santi,
ritrovate a Trieste. All'edificio era associato, almeno dal
secolo X, un monastero di Benedettini, che rifabbricarono completamente
la chiesa dal 1065 al 1143 seguendo il modello cistercense francese
di Cluny II, a tre navate terminate da absidi e transetto anch'esso
absidato. Particolarità di San Fermo ("Maggiore" per distinguerlo
dallo scomparso San Fermo Minore, sorto nel XII secolo sul supposto
luogo del martirio dei santi, in riva all'Adige presso l'odierno
ponte Aleardi) è la struttura a due chiese sovrapposte: quella
inferiore non è limitata alla zona presbiteriale come una cripta
tradizionale, ma ha uno sviluppo in lunghezza che corrisponde
alla dimensione completa della antica chiesa benedettina. Nel
1261 i frati Minori, che erano in San Francesco al Corso, all'esterno
delle mura, ottennero di insediarsi nel convento di San Fermo
in luogo dei Benedettini ed entro la fine del '200 iniziarono
la ricostruzione in forme gotiche della chiesa superiore. Fu
da loro eliminata la divisione tra le navate, demolito e rifatto
in forma poligonale l'abside maggiore, innalzata e allungata
la navata. Dell' edificio romanico, i cui muri perimetrali vennero
in pane riutilizzati, rimasero così la chiesa inferiore, le
quattro absidi laterali e la base del campanile. Un accentuato
carattere gotico fu conferito all'esterno dagli agili coronamenti
a timpani e pinnacoli, dalle ampie finestre cuspidate e dalle
cornici ad archetti pensili trilobati o intrecciati, di ascendenza
lombarda, che contornano la chiesa. Nel fianco verso la strada
si apre un grande portale gemino a marmi policromi del primo
'300, analogo al coevo portale maggiore di Sant' Anastasia,
di cui è probabile sia stato il modello. E logico infatti attribuire
ai Francescani l'introduzione a Verona di questo tipo di portale
doppio, diffusissimo oltralpe, ma il cui principale, se non
unico, precedente in Italia è nelle porte della basilica di
S.Francesco ad Assisi. All'inizio del '400 venne aggiunto il
protiro che protegge l'accesso e alla fine di quel secolo venne
posta nella lunetta del portale la statua policroma di sant'Antonio
di Padova, donata dai Banda assieme a quella di san Francesco
sulla porta principale. Una Sacra Conversazione di Francesco
Morone, firmata e datata 1523, è affrescata sul muro laterale.
La facciata, che riutilizza un precedente portale romanico strombato,
doveva essere compiuta prima del 1385, quando vi veniva posta
la tomba pensile di Aventino Fracastoro, medico degli Scaligeri.
L'affresco altichieresco con L'Incoronazione della Vergine che
ornava la lunetta sopra il sarcofago è ora al Museo di Castelvecchio.
Sull' altro lato è il padiglione di un'arca del tardo '200 riutilizzata
dai Tolentino nel XV secolo. La parte inferiore in pietra della
facciata è terminata da una galleria di finestrelle, quattro
delle quali sono cieche e mostrano figure trecentesche di santi
francescani. La zona superiore, ampiamente forata al centro
dalle finestre sovrapposte, adotta il caratteristico paramento
a corsi alternati di mattone e pietra. La porta bronzea con
Storia del martirio dei santi Fermo e Rustico è opera di Luciano
Minguzzi. Il vasto interno, funzionale all'esigenza della predicazione,
è coperto da un magnifico soffitto ligneo a carena di nave (XIV
secolo), ornato da una doppia galleria di archetti in cui sono
dipinti busti di santi. Sull'arco del presbiterio esso contorna
i ritratti contrapposti di Guglielmo di Castelbarco (+ 1320),
che offre un modellino della chiesa, e frà Daniele Gusmerio,
guardiano del convento tra 1318 e 1320, protagonisti della fase
principale della ricostruzione trecentesca. Sulla lunetta sopra
la porta principale è affrescata una Crocifissione di Turone
di Maxio (1), cui è attribuita anche la Crocifissione sulla
porta laterale (2), datata 1363. Sulla parete destra, verso
l'angolo, tre superstiti scene trecentesche del Martirio dei
Francescani in India (3), dal racconto del viaggiatore francescano
Odorico da Pordenone (vivacissimo il quadro inferiore, con l'imperatore
di Delhi che fa giustiziare i persecutori dei frati e i diavoli
che si impossessano delle loro anime). |
| All'adiacente
cappella Nichesola (4) di eleganti forme rinascimentali dell'inizio
del '500, è stato adattato un altare cinquecentesco dei Murari
Bra con pala di Sante Creara, trasferito da altra chiesa nel
1816. Dopo un affresco staccato con Coro d'angeli di Stefano
da Verona (5), è il pulpito donato dal giurista Barnaba da Morano
(6), datato 1396 (ma il parapetto è stato rifatto nel primo
'500), probabile opera dello scultore Antonio da Mestre, attorniato
da pitture firmate da Martino da Verona raffiguranti Evangelisti
e dottori della Chiesa in cattedra, profeti e personaggi illustri.
In alto, Mosè ed Elia, che alludono a san Francesco, tradizionalmente
designato "nuovo Mosè" e "nuovo Elia" nella esegesi francescana.
All'interno della Cappella Brenzoni (7) si trova l'arca di Barnaba
da Morano (+ 1411) (8), opera di Antonio da Mestre, qui trasportata
dalla parete a destra della porta principale, con alcuni degli
affreschi di Marcino da Verona che la circondavano, raffiguranti
il Giudizio Universale. La decorazione pittorica originale comprendeva
anche santi in edicole gotiche, ancora in sito, e un Incontro
dei tre vivi con i tre morti (Memento Mori tardo-gotico di origine
francese). Dopo la cappella si trovano l'arca di Torello Saraina
(9), storico veronese del '500, accanto all'altare (10) da lui
eretto (1523), primo a Verona ad ispirarsi al romano Arco dei
Gavi. La pala di Francesco Torbido, Trinità, Vergine con il
Bambino tra l'arcangelo Raffaele e santa Giustina, una delle
sue migliori, andrebbe datata attorno al 1530 per i manifesti
contatti con le opere mantovane di Giulio Romano. Sotto la mensa,
sculture di una Deposizione nel sepolcro dell' 400. La sagrestia
(11), donata dai Fracastoro nel 1528, è ornata di arredi e quadri
del '600 (Storie di sant'Antonio di Padova). Il transetto destro,
che conserva affreschi del '300 con Storie di san Francesco
frammentarie, ospita la cappella degli Alighieri (1540 circa),
linea veronese dei discendenti di Dante (12). Vi è accuratamente
ripreso il fronte dell' Arco dei Gavi. La pala cinquecentesca
di Battista Del Moro raffigura la Vergine con il Bambino tra
i santi Pietro, Zeno e Francesco. Nell'absidiola del transetto
(13), sotto l'altare, Deposizione del '300. La seicentesca cappella
degli Agonizzanti (14), a lato del presbiterio, ha una Crocifissione
di Domenico Brusasorci. L'area Presbiteriale è delimitata da
un grande tornacoro colonnato (1573), che riprende la soluzione
ideata dal Sanmicheli per il Duomo quarant'anni prima. L'altare
maggiore venne rifatto nel 1759 su disegno di Giuseppe Antonio
Schiavi, in occasione della traslazione delle reliquie dei martiri
Fermo e Rustico dalla chiesa inferiore, dove erano minacciate
dalle inondazioni dell'Adige. Nelle vele del catino absidale
(15), Redentore e santi, affreschi del primo '300 del cosiddetto
Maestro del Redentore, artista che introduce il linguaggio giottesco
a Verona, autore pure dei Simboli degli Evangelisti sulla volta
a crociera e dei ritratti di Castelbarco (16) e Grommo (17)
sull'arco esterno (che recavano la data 1314). Al di sotto di
questi ultimi, Incoronazione della Vergine e Adorazione dei
Magi, di Lorenzo Veneziano. La successiva cappella di sant'Antonio
(18), ridecorata in forme barocche come quella opposta degli
Agonizzanti, ha sull' altare una pala quattrocentesca, Sant'Antonio
fra i santi Agostino e Nicolò, di Liberale da Verona. Nella
spoglia cappella Della Torre (19), cui si accede dal transetto
sinistro, è il magnifico mausoleo rinascimentale di Girolamo
e Marcantonio Della Torre (1511 circa), con otto bassorilievi
bronzei del padovano Andrea Riccio (ora presenti in copia: gli
originali sono stati portati al Louvre nel 1797), che rappresentano
la vita, la malattia e la morte di Girolamo della Torre. |
| Le
scene, con i riti di trapasso all'oltretomba, sono collocate
nell'antichità pagana. I defunti, padre e figlio, appartenevano
a una cerchia di umanisti, scienziati e filosofi, e sono ritratti
in due maschere funebri alla sommità dell'arca, sorretta da
quattro sfingi. Nel bassorilievo sul lato opposto all'ingresso
figura il mausoleo stesso. L'altare dell'Arte dei falegnami
(20), eretto nel 1608, reca una delle prime opere di Alessandro
Turchi, importante pittore veronese del '600, un'Adorazione
dei Pastori con i santi Girolamo, Antonio abate e Giuseppe.
Verso la porta laterale della chiesa si apre la grande cappella
della Concezione (21), fondata nel '400 a spese della città
e in origine dedicata a san Bernardino, prima ancora che il
santo venisse canonizzato. Passò poco dopo in proprietà dei
Banda, che la tennero fino al XVII secolo. La decorazione seicentesca
conserva il ricordo della tragica pestilenza del 1630, a cavallo
della quale fu realizzata: si veda sulla destra la pala di Antonio
Giarola con Verona che invoca la Trinità per essere liberata
dalla peste. Sull'altare, pala firmata e datata al 1528 da Francesco
Caroto, La Vergine con sant'Anna e i santi Sebastiano, Rocco,
Pietro e Giovanni Battista, da Vasari in poi considerata tra
le sue opere migliori. L'altare lombardesco accanto alla porta
(22) apparteneva all'Arte dei barcaioli (1535), che lo fece
ornare con una notevole pala di Battista del Moro, San Nicola
(patrono dei naviganti) tra sant'Agostino e sant'Antonio abate.
Presso l'angolo con la facciata (23) è il mausoleo di Nicolò
Brenzoni (1424-26), celebre monumento funerario dovuto per la
pane scultorea, con la Resurrezione, al fiorentino Nanni di
Banolo e per la decorazione pittorica a Pisanello. Questo elaborato
tipo di tomba murale, con sarcofago sormontato da un baldacchino
attorniato da sculture e affreschi, contenuto in una grande
cornice, ricorda il monumento Serego in Sant' Anastasia, degli
stessi anni, ed esempi dogali veneziani (sia Pisanello che Nanni
di Banolo lavoravano a Venezia in questo periodo). L'Annunciazione
di Pisanello agli angoli superiori della cornice e la elaborata
pergola dipinta a fare da sfondo, come fosse un arazzo, sono
un vertice dello stile di estrema eleganza cortese del Gotico
Internazionale. Per una porta nel transetto destro si scende
al chiostro, dove sul retro della scala è la sobria lastra funeraria,
simile ad altra sulla facciata di San Giorgetto, del medico
Antonio Pelacani (+ 1327) in cattedra (24). Sui libri aperti
del maestro e dei discepoli sono gli aforismi di Ippocrate:
Vita brevis / Ars longa / Tempus acutum / Experimentum fallax
/ ludicium difficile. Una scala conduce dal chiostro alla chiesa
inferiore, che conserva l'aspetto della costruzione romanica,
con volte sostenute da tre file di pilastri in pietra, ornati
da affreschi dei secoli XII-XlV: Sul quinto pilastro della navata
sinistra, un Battesimo di Cristo del XIII secolo (25), ben conservato
per essere stato scoperto di recente sotto uno strato di intonaco.
Sul penultimo pilastro della navata destra è incisa l'iscrizione
che fisserebbe l'inizio della costruzione al 1065 (26) e in
fondo alla stessa navata è stato posto sulla parete il sigillo
sepolcrale dei Banda (27), già nella cappella della Concezione
che apparteneva alla famiglia, opera finissima della fine del
'400. Nel transetto sinistro è la spartana lastra tombale di
fra' Daniele Gusmerio (+ 1332), promotore della ricostruzione
francescana (28). Le colonne nell' abside centrale, nel quale
è un Crocifisso ligneo trecentesco (29), hanno capitelli ionici
di spoglio che furono presi spesso a modello dagli artisti del
primo rinascimento veronese. |
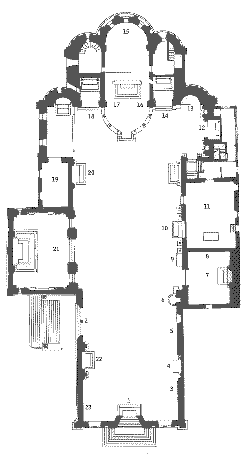 |
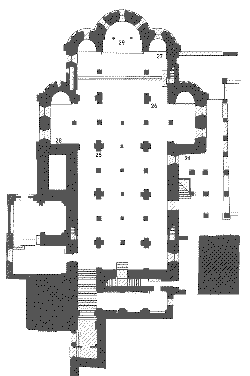 |
| superiore |
inferiore |
|
|
|