Thomas Hobbes vive nell’Inghilterra del XVII secolo, segnata dallo scontro tra il potere preteso dal sovrano e le libertà richieste dai sudditi. Nel Leviatano egli sostiene che la convivenza umana può darsi solo entro lo stato. Per dimostralo identifica i motivi che rendono necessario fissare regole nei rapporti tra gli uomini.
La natura ha fatto gli uomini così uguali nelle facoltà del corpo e della mente che, benché talvolta si trovi un uomo palesemente più forte, nel fisico, o di mente più pronta di un altro, tuttavia, tutto sommato, la differenza tra uomo e uomo non è così considerevole al punto che un uomo possa da ciò rivendicare per sé un beneficio cui un altro non possa pretendere tanto quanto lui. Infatti, quanto alla forza corporea, il più debole ne ha a sufficienza per uccidere il più forte, sia ricorrendo a una macchinazione segreta, sia alleandosi con altri che corrono il suo stesso pericolo.
Quanto alle facoltà della mente (…) trovo che tra gli uomini vi sia un’eguaglianza ancora più grande di quella della forza fisica. Infatti, come la prudenza non è che esperienza la quale, in tempi uguali, viene dispensata in egual misura a tutti gli uomini per le cose cui si applicano in egual misura (…).
Da questa uguaglianza di capacità nasce un’uguaglianza nella speranza di raggiungere i propri fini. Perciò, se due uomini desiderano la medesima cosa, di cui tuttavia non possono entrambi fruire, diventano nemici e, nel perseguire il loro scopo (che è principalmente la propria conservazione e talvolta solo il proprio piacere) cercano di distruggersi o di sottomettersi l’un l’altro (…).
A causa di questa diffidenza dell’uno verso l’altro, non esiste per alcun uomo mezzo di difesa così ragionevole quanto l’agire d’anticipo, vale a dire l’assoggettare, con la violenza o con l’inganno, la persona di tutti gli uomini che può, fino a che non vede nessun altro potere abbastanza grande da metterlo in pericolo; ciò non è niente più di quanto esiga la conservazione di se stesso, ed è cosa in generale ammessa (…). Cosicché, troviamo nella natura umana tre cause principali di contesa: in primo luogo la rivalità; in secondo luogo la diffidenza; in terzo luogo l’orgoglio (…).
Da ciò, appare chiaramente che quando gli uomini vivono senza un potere comune che li tenga tutti in soggezione, essi si trovano in quella condizione chiamata guerra: guerra che è quella di ogni uomo contro ogni altro uomo (…).
Da questa guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo consegue anche che niente può essere ingiusto. Le nozioni di diritto e torto, di giustizia e di ingiustizia non vi hanno luogo. Laddove non esiste un potere comune, non esiste legge; dove non vi è legge non vi è ingiustizia (…).
Le passioni che inducono gli uomini alla pace sono la paure della morte, il desiderio di quelle cose che sono necessarie a una vita piacevole e la speranza di ottenerle con la propria operosità ingegnosa. E la ragione suggerisce opportune clausole di pace sulle quali si possono portare gli uomini a un accordo. Queste clausole sono quelle che vengono, in altri termini, chiamate le leggi di natura.
T. Hobbes, Leviatano, a cura di A. Pacchi, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 99-104.
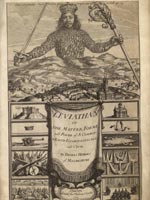
Frontespizio del Leviatano
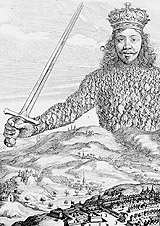
Particolare del leviatano
![]()
Thomas Hobbes visse in
un periodo particolarmente tormentato della storia inglese . La tendenza
degli Stuart ( prima Giacomo I , poi Carlo I ) ad accentrare il potere
nelle mani del
 re
aveva provocato gravi tensioni tra la Corona e il Parlamento, una parte
del quale - la Camera dei Comuni - rappresentava gli interessi di una
classe media sempre più intenzionata a far sentire il proprio peso nella
vita della nazione . Gli squilibri politici erano inoltre strettamente
intrecciati con quelli religiosi. Da un lato la politica accentratrice
della monarchia si rifletteva sulla struttura episcopale della Chiesa
anglicana che, pur essendosi resa indipendente da quella di Roma, ne eveva
conservato oltre ai dogmi , anche l'organizzazione gerarchica e
autoritaria; dall'altro i presbiteriani accoglievano l'esigenza puritana
di una maggiore de-cattolicizzazione della Chiesa inglese e di
un'articolazione più democratica del clero che avrebbe dovuto essere
eletto dal basso, cioè dai fedeli stessi organizzati in comunità
parrocchiali (presbiteri), anzichè venire nominato dall'alto del potere
vescovile. Questi conflitti politico religiosi condussero l'Inghilterra
alla guerra civile, alla condanna e alla decapitazione di Carlo I e alla
successiva dittatura repubblicana di Oliver Cromwell. Quest'ultima fu
espressione, sul piano politico, della media borghesia e, su quello
religioso, di una variante puritana più radicale dei presbiteriani - gli
Indipendenti , che pretendevano una completa autonomia della Chiesa dal re
e dal potere politico. La storia dell'Inghilterra della prima metà del
Seicento è dunque in gran parte la vicenda del confronto tra i sostenitori
dell'assolutismo monarchico e dell'episcopalismo e dei difensori di una
più o meno grande redistribuzione del potere che consentisse maggiori
margini di autonomia agli strati medio-bassi della borghesia e della
Chiesa. . Sebbene di estrazione piccolo-borghese - era nato a Malmesbury
nel 1588 da un pastore di campagna - Hobbes si schierò decisamente a
favore del partito realista e della Chiesa anglicana. Ciò è stato in parte
spiegato con il suo carattere timoroso , pieno di orrore per ogni
sedizione e disordine civile, in parte con il fatto che egli visse
lungamente al servizio e sotto la protezione dei potenti: fu precettore di
due generazioni di Cavendish, futuri duchi del Devonshire, nel castello
dei quali concluderà i sui giorni, ed insegnò matematica al futuro Carlo
II che, diventato re, lo proteggerà nell'ultima parte della sua lunga
vita. In ogni caso la scelta di Hobbes è in piena sintonia con la sua
teoria secondo cui l'unico modo per garantire la pace e la sicurezza
civile è la concentrazione di tutto il potere delle mani di uno solo. Se
il pensiero politico di Hobbes è fortemente influenzato dalle vicende
storiche da lui vissute, la sua formazione filosofica dipende in gran
parte dai lunghi soggiorni che egli trascorse nel Continente. Dopo aver
conseguito nel 1608 il bacca-laureato delle Arti ad Oxford, dal 1610 al
1612 egli accompagna il discepolo William Cavedish in un viaggio in
Europa. Questo primo contatto con la cultura continentale verrà
consolidato da altre permanenze, soprattuttto in Francia e in Italia,
negli anni 1629-31, 1634-37, 1640-51. L'ultima di esse è un volontario
esilio, motivato da ragioni di sicurezza: nel 1640 egli aveva fatto
circolare manoscritti gli Elementi di legislazione naturale e politica ,
in un momento in cui si radicalizzava la lotta tra il re e il Parlamento.
Durante questi viaggi Hobbes ebbe occasione di conoscere Galilei ad
Arcetri e, a Parigi, Gassendi , Mersenne (su invito del quale scrisse le
terze Obiezioni alle Meditazioni di Cartesio) e molti esponenti
dell'ambiente libertino. Si delineavano così alcuni aspetti essenziali del
suo pensiero: l'assunzione del modello matematico in filosofia,
l'attenzione per il razionalismo cartesiano, corretto però dall'empirismo
di Gassendi, la critica razionalistica alla religione che sfiora
l'ateismo. Durante il soggiorno parigino Hobbes pubblica il De cive (1642)
, che costituisce l'ultima parte di una trilogia filosofica-politica , gli
Elementa philosophiae , le cui prime due componenti, il De corpore e il De
homine, usciranno rispettivamente nel 1655 e nel 1658, dopo il rientro in
Inghilterra. Prima di ritornare in patria egli pubblica tuttavia la sua
opera principale, il Leviatano (1651), che costituisce la summa del suo
pensiero, anche se la discussione dei problemi politici è nettamente
prevalente sull'esposizione dei temi gnoseologici ed etici . Caduto
Cromwelle restaurata la monarchia, Hobbes trova un valido protettore nella
persona di Carlo II, suo antico discepolo. Morirà a Londra, più che
novantenne nel 1679 .
re
aveva provocato gravi tensioni tra la Corona e il Parlamento, una parte
del quale - la Camera dei Comuni - rappresentava gli interessi di una
classe media sempre più intenzionata a far sentire il proprio peso nella
vita della nazione . Gli squilibri politici erano inoltre strettamente
intrecciati con quelli religiosi. Da un lato la politica accentratrice
della monarchia si rifletteva sulla struttura episcopale della Chiesa
anglicana che, pur essendosi resa indipendente da quella di Roma, ne eveva
conservato oltre ai dogmi , anche l'organizzazione gerarchica e
autoritaria; dall'altro i presbiteriani accoglievano l'esigenza puritana
di una maggiore de-cattolicizzazione della Chiesa inglese e di
un'articolazione più democratica del clero che avrebbe dovuto essere
eletto dal basso, cioè dai fedeli stessi organizzati in comunità
parrocchiali (presbiteri), anzichè venire nominato dall'alto del potere
vescovile. Questi conflitti politico religiosi condussero l'Inghilterra
alla guerra civile, alla condanna e alla decapitazione di Carlo I e alla
successiva dittatura repubblicana di Oliver Cromwell. Quest'ultima fu
espressione, sul piano politico, della media borghesia e, su quello
religioso, di una variante puritana più radicale dei presbiteriani - gli
Indipendenti , che pretendevano una completa autonomia della Chiesa dal re
e dal potere politico. La storia dell'Inghilterra della prima metà del
Seicento è dunque in gran parte la vicenda del confronto tra i sostenitori
dell'assolutismo monarchico e dell'episcopalismo e dei difensori di una
più o meno grande redistribuzione del potere che consentisse maggiori
margini di autonomia agli strati medio-bassi della borghesia e della
Chiesa. . Sebbene di estrazione piccolo-borghese - era nato a Malmesbury
nel 1588 da un pastore di campagna - Hobbes si schierò decisamente a
favore del partito realista e della Chiesa anglicana. Ciò è stato in parte
spiegato con il suo carattere timoroso , pieno di orrore per ogni
sedizione e disordine civile, in parte con il fatto che egli visse
lungamente al servizio e sotto la protezione dei potenti: fu precettore di
due generazioni di Cavendish, futuri duchi del Devonshire, nel castello
dei quali concluderà i sui giorni, ed insegnò matematica al futuro Carlo
II che, diventato re, lo proteggerà nell'ultima parte della sua lunga
vita. In ogni caso la scelta di Hobbes è in piena sintonia con la sua
teoria secondo cui l'unico modo per garantire la pace e la sicurezza
civile è la concentrazione di tutto il potere delle mani di uno solo. Se
il pensiero politico di Hobbes è fortemente influenzato dalle vicende
storiche da lui vissute, la sua formazione filosofica dipende in gran
parte dai lunghi soggiorni che egli trascorse nel Continente. Dopo aver
conseguito nel 1608 il bacca-laureato delle Arti ad Oxford, dal 1610 al
1612 egli accompagna il discepolo William Cavedish in un viaggio in
Europa. Questo primo contatto con la cultura continentale verrà
consolidato da altre permanenze, soprattuttto in Francia e in Italia,
negli anni 1629-31, 1634-37, 1640-51. L'ultima di esse è un volontario
esilio, motivato da ragioni di sicurezza: nel 1640 egli aveva fatto
circolare manoscritti gli Elementi di legislazione naturale e politica ,
in un momento in cui si radicalizzava la lotta tra il re e il Parlamento.
Durante questi viaggi Hobbes ebbe occasione di conoscere Galilei ad
Arcetri e, a Parigi, Gassendi , Mersenne (su invito del quale scrisse le
terze Obiezioni alle Meditazioni di Cartesio) e molti esponenti
dell'ambiente libertino. Si delineavano così alcuni aspetti essenziali del
suo pensiero: l'assunzione del modello matematico in filosofia,
l'attenzione per il razionalismo cartesiano, corretto però dall'empirismo
di Gassendi, la critica razionalistica alla religione che sfiora
l'ateismo. Durante il soggiorno parigino Hobbes pubblica il De cive (1642)
, che costituisce l'ultima parte di una trilogia filosofica-politica , gli
Elementa philosophiae , le cui prime due componenti, il De corpore e il De
homine, usciranno rispettivamente nel 1655 e nel 1658, dopo il rientro in
Inghilterra. Prima di ritornare in patria egli pubblica tuttavia la sua
opera principale, il Leviatano (1651), che costituisce la summa del suo
pensiero, anche se la discussione dei problemi politici è nettamente
prevalente sull'esposizione dei temi gnoseologici ed etici . Caduto
Cromwelle restaurata la monarchia, Hobbes trova un valido protettore nella
persona di Carlo II, suo antico discepolo. Morirà a Londra, più che
novantenne nel 1679 .
![]()
