L'uomo da sempre ha dovuto e voluto
affrontare uno dei problemi più affascinanti: il dominio dell'aria, oramai divenuto una
delle maggiori conquiste dell'umanità. Modelli per il volo furono gli animali dotati di
ali. Gli studiosi osservarono sia gli organi che permettevano a tali animali di volare sia
le tecniche di volo. Il volo era sinonimo di perfezione tanto che anche le figure degli
angeli, come esseri superiori, sono legate a grandi ali candide che permettono loro il
volo.
Lo studio delle macchine volanti si divise in macchine più leggere e in macchine più
pesanti dell'aria.
Come sono fatti e che principi sfruttano
aerostati e dirigibili
Il primo volo con un equipaggio umano risale al 1783 quando i fratelli Montgolfier
volarono con un pallone ad aria calda. Oggi gli aerostati sono usati solo per scopi
ricreativi oppure per il rilevamento dati dei meteorologi, tuttavia all'inizio del XX
secolo gli aerostati a motore, chiamati dirigibili, facevano concorrenza agli aeroplani
come mezzi di trasporto aereo anche se oggi hanno solo scopi pubblicitari o sono
utilizzati come piattaforme per telecamere.
Viene detto aerostato un involucro che racchiude una massa gassosa avente un peso
specifico minore di quello dell'aria. L'involucro di un aerostato o di un dirigibile
sposta un grande volume d'aria, generando una forza chiamata spinta aerostatica. Si usa
munire la camera del gas con un'appendice, che ha l'estremità aperta ad una certa
distanza sotto l'involucro così che la pressione interna sia uguale a quella esistente
alla bocca dell'appendice. Nei dirigibili al posto di questa appendice vengono utilizzate
valvole che ottengono lo stesso risultato. I palloni ad aria calda si sollevano quando
l'aria nell'involucro è riscaldata perché ciò la rende meno densa rispetto all'aria
dell'atmosfera circostante più fredda. Per i calcoli aeronautici si suppone che
l'atmosfera abbia date condizioni ideali, corrispondenti ad un'atmosfera tipo costituita
da una temperatura media di 15° e densità di circa 1,226 kg/m3 si tiene in oltre conto
che salendo la temperatura decresce.
Per il gonfiamento dei palloni oramai nessuno usa l'aria calda, se non nei palloni di
carta usati per gioco, si ricorre quindi a gas luce (utilizzato soprattutto nel passato
perché costituito da metano molto leggero) oppure ad idrogeno od elio. Il peso specifico
dell'aria a livello del mare è di circa 1,226kg/m3 mentre il peso specifico dell'idrogeno
e dell'elio sono rispettivamente 0,09 kg/m3 e 0,18kg/m3 anche se è necessario tener conto
del fatto che i gas non sono mai puri per cui la densità aumenta lievemente. La forza
ascensionale totale diminuita del peso globale dei carichi e della struttura dà la forza
ascensionale libera che va a costituire l'effettiva spinta in alto dell'aerostato.
Tale forza deve essere mantenuta tra il 2 e il 5 % del peso totale.
Quando il pallone sale, diminuisce la pressione esterna; il gas interno si espande e in
parte sfugge dall'appendice, o dalle valvole; quando il pallone scende la pressione
esterna cresce e comprime il gas interno, che rimane costretto in un volume via via minore
e mentre nella salita rimane costante il volume del gas e non il peso in discesa si ha il
contrario. Tale costanza si può realizzare anche nella salita, facendo in modo che il
gas, dilatandosi, scacci aria dal fuso aerostatico. Nell'aerostato a volume costante, in
salita, la forza ascensionale varia in modo proporzionale alla diminuzione della densità
dell'aria esterna. Perché la salita si arresti è necessario che da un certo punto in poi
si perda gas dalle valvole o dall'appendice. Raggiunta la quota di equilibrio, cessa la
possibilità di salita, tuttavia qualora una causa accidentale, come la condensazione di
vapore, determini la discesa, questa si protrae senza limiti occorre dunque frenarla con
il getto delle zavorre.
Il pallone in libera salita segue due ordini di movimenti: uno ascensionale, l'altro
orizzontale.
Sul moto verticale il pilota può agire solo entro certi limiti, infatti, nell'ascesa può
accrescere la forza ascensionale libera gettando zavorra; nella discesa si diminuisce tale
forza lasciando fuggire gas. Dal punto di vista dei moti orizzontali dovuti al vento non
avendo l'aerostato mezzi propri di propulsione viene trasportato dall'aria.
Per quanto riguarda l'attrezzatura l'aerostato è dotato di un involucro di forma sferica.
Su questo involucro vi è una rete inferiormente terminante con maglie foggiate a zampe
d'oca e con robusti fili, appoggiati a un anello di legno che fanno da sostegno per la
navicella dell'aeronauta.
Il pilota ha a portata di mano i tiranti per manovrare la valvola di sicurezza, disposta
sotto il cappello conico che sormonta l'involucro. Vi è poi un altro tirante collegato ad
una striscia saldata all'involucro, striscia che può essere strappata in casi d'urgenza.
Dalla parte inferiore del pallone scende una manichetta di tela, che avvolge il tubo di
uscita del gas o appendice.
Per favorire l'atterraggio si usano ancore simile a quelle per l'ormeggio di una nave.
 Il vascello volante di Padre Lana |
Inizialmente più che i tentativi di singoli audaci, i veri progressi si ottennero grazie alle conquiste scientifiche nel campo dell'arte del volo. In primissima linea si presenta Leonardo da Vinci che per primo, studiando il meccanismo del volo degli uccelli, intuì i fondamentali principi che trovano applicazione nelle macchine moderne. Un ulteriore aiuto arrivò dalla scoperta delle proprietà dell'aria e dei gravi per merito di Galileo e Newton, solo per citare i due più conosciuti. Il primo che, intorno al 1670, ideò un apparecchio più leggero dell'aria fu Padre Francesco Lana, scienziato, matematico, naturalista, pedagogo e gesuita. Progettò il cosiddetto “vascello volante”: si trattava di una nave che veniva sollevata da sfere di rame vuote di aria. Tale apparecchio non venne mai costruito. Nonostante la macchina rimase un semplice progetto il tribunale dell'Inquisizione processò ugualmente Padre Lana. |
Stessa sorte toccò a Padre Gusmao che
nel 1709 alla presenza del Re di Portogallo e di una folla numerosa si elevò in aria
sostenuto da un globo più leggero dell'aria forse riempito di un gas sviluppato da
limatura di ferro posta in vetriolo, praticamente idrogeno, altri ritengono che in realtà
egli riempì il pallone con aria calda. Nel 1766 dopo la scoperta dell'idrogeno Tiberio
Cavallo, professore a Londra ma di origine italiana, usò l'idrogeno per riempire palloni
impermeabili dimostrando che con quel gas era possibile il sollevamento nell'aria. Tutte
questi tentativi caddero nel dimenticatoio dopo le esperienze di Joseph e Jacques
Montgolfier che dopo aver osservato i moti delle nubi e scelto, dopo vari tentativi ed
insuccessi, l'aria calda per permettere il sollevarsi della mongolfiera il 5 maggio 1783
con un pallone di 12 metri di diametro costruito con tela e carta con un panierino di
ferro dove ardeva un miscuglio di paglia umida e lana si sollevarono tra l'entusiasmo di
tutti. Non recavano persone a bordo ma finalmente la prova dell'ascensione era raggiunta.
Dopo l'entusiasmo di questo avvenimento iniziò un dilagarsi di esperienze per continuare
con miglioramenti. Il fisico Charles costruì un pallone di seta con una capacità di 40m3
che vennero riempiti di idrogeno. Il pallone in due minuti raggiunse un'altezza di 2000 m
e subito dopo si allontanò dalla città ricadendo in campagna. I primi aeronauti ascesi
in mongolfiera furono tre animali che tornarono sani e salvi dal volo così Pilattre de
Rozier un audace professore, con il marchese D'Arlandes, il 21 ottobre del 1783 compì un
tragitto aereo. Questo susseguirsi di prove, studi e perfezionamenti consentirono il
raggiungimento di essenziali progressi in poco tempo. Il 21 novembre prese il volo Lunardi
ambasciatore del regno di Napoli il 19 dicembre lo stesso Charles compì un'ascensione a
Parigi adottando l'uso della zavorra e dell'appendice. Nel 1784 un tenente francese,
Meusnier, propose di passare dall'aerostato al dirigibile. Il progetto mirava alla
costruzione di un elissoide con una capacità di 80.000 m3. Ad esso sarebbero stati appesi
una navicella e eliche di propulsione mosse a mano da operai. Tale progetto non venne
tuttavia eseguito. Nello stesso anno in Inghilterra grande ammirazione per i suoi voli
destava Lunardi in Italia volavano in mongolfiera i fratelli Gelli In Francia i fratelli
Robert che costruirono un dirigibile tuttavia molto pericoloso durante l'atterraggio. Nel
1785 Pilatre de Rozier morì in un disastro dovuto ad un'associazione di aria calda e di
idrogeno in compartimenti adiacenti. Nel 1785 venne compiuto il sorvolo della Manica. Un
pallone fu elevato a Parigi il giorno in cui Napoleone venne incoronato imperatore nel
1804 anche se il pallone il giorno seguente vagava attorno al Vaticano e dopo aver
sorvolato le campagne romane si franse contro la tomba di Nerone.
Il pallone Zenith il 15 aprile 1875 si elevava sino a 8600 m a scopo di studio ma di tre
aeronauti due morirono per deficienza di ossigeno. Nel 1894 il pallone tedesco Phoeniz con
a bordo il Dr. Berson, ritentò tale esperienza munendosi di respiratori artificiali
riuscendo a raggiungere i 9400 m. Nel 1932 infine Piccard e Kipfer riuscirono a
raggiungere i 16.000 m.
| Il primo mezzo
di trasporto aereo fu il pallone, che nel settecento venne utilizzato per scopi civili e
militari. Il pallone da solo non era sufficiente, i progressi nel campo della propulsione
portarono alla nascita di un mezzo aereo più completo e flessibile: il dirigibile. Il primo fu costruito da Henri Giffard, era un’aeronave spinta da un’elica azionata da un motore a vapore. Il motore non presentava caratteristiche e potenze adeguate alle necessità, con il motore a combustione interna i dirigibili poterono svilupparsi e incontrare i primi successi. Il primo di questi mezzi appartenente al brasiliano Alberto Santos-Dumont, volò nel 1898 a Parigi, ed egli, colpito da questa passione, ne progettò ben 18 tipi. I dirigibili si sviluppano in tre categorie: · quelli di tipo FLOSCIO: la forma dell’involucro esterno è mantenuta solo dalla pressione del gas contenuto all’interno. · quelli di tipo SEMIRIGIDO: la forma è mantenuta sia dalla pressione del gas che dalla presenza di un trave metallico. · quelli di tipo RIGIDO: la forma esterna è garantita da un’armatura metallica complessa. Il primo dirigibile rigido motorizzato fu tedesco e fu realizzato nel 1975 da Paul Haenlein, mentre nel 1888 Kurt Wolfert realizzò il primo dirigibile dotato di un motore aeronautico. Von Zeppelin, considerato il padre dei dirigibili, nacque a Costanza nel 1838, dopo la guerra Austro-Prussiana e quella Franco-Prussiana abbandonò la carriera militare per dedicarsi allo sviluppo dei mezzi più leggeri dell’aria, e nel 1898 fondò la ditta Zeppelin. Zeppelin cercò di interessare l’esercito tedesco alle sue proposte, ma si scontrò con la concorrenza di Von Parseva (dirigibile di tipo floscio) e di Gross (dirigibile di tipo semirigido). |
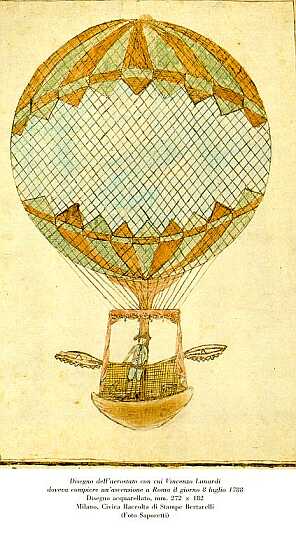 |
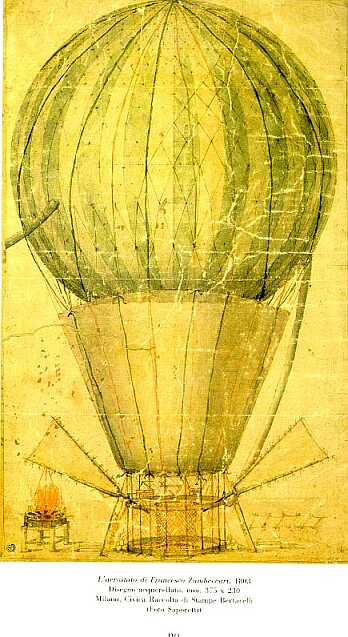 |
Il successo dei progetti
Zeppelin fu dovuto al fatto che vennero realizzati dirigibili rigidi di grandi dimensioni. Il primo modello fu l’LZ-1 (lungo: 128m; largo: 11,66m; volume: 11.300m3) che però aveva una scarsa potenza di due motori da 16 CV che lo facevano viaggiare a 45km/h. Nel 1905 anche la marina tedesca ordinò i suoi primi quattro dirigibili, per compiti di ricognizione. Nello stesso anno Zeppelin fondò la DELAG, la prima compagnia aerea commerciale dotata di dirigibili; nel 1910 venne effettuato il primo volo con l’LZ-7 che portava 24 passeggeri. Nei quattro anni di attività della DELAG, la compagnia trasportò 10.000 passeggeri effettuò 3.193 ore di volo, pari a 172.535 km percorsi. Con lo scoppio della 1° guerra mondiale gli Zeppelin vennero utilizzati anche per il bombardamento delle città. Con il proseguo del conflitto le difese si fecero sempre più efficaci e quindi nel 1916 ci fu l’ultima missione di un dirigibile. Nel dopoguerra la compagnia DELAG riprese le operazioni e Zeppelin continuò a sviluppare dirigibili rigidi sempre più grandi e capaci. |
| Nel 1928 prese il volo
l’LZ-127 un’aeronave immensa di 236m di lunghezza, con un volume di 111.000m3;
il mezzo era spinto da quattro motori da 550 CV che lo portano a una velocità di 128
km/h. Nel 1929 l’aeronave, che poteva accogliere sino a 38 passeggeri, inaugurò il servizio transatlantico verso il nord e il sud America, effettuando in 29 giorni il giro del mondo. Il più grande e il più famoso dei dirigibili Zeppelin fu l’L-129 con 245m di lunghezza, un volume di 200.000m3, quattro motori da 1050 CV gli davano una velocità di 135km/h e un’autonomia di 14.500km. |
 Dirigibile Santos-Dumont del 1898 |
 |
Effettuò il suo primo volo
nel 1936 e portò a compimento 63 voli prima del tragico incidente che lo distrusse
completamente, questa tragedia segnò il declino dei dirigibili, che erano già stati
superati sul piano tecnico dagli aerei. Grazie a Umberto Nobile spiccò anche l’Italia nella costruzione dei dirigibili; nato ad Avellino venne assegnato all’ufficio tecnico dello stabilimento di costruzioni aeronautiche di Roma. Nobile diede vita al T34, un dirigibile semirigido battezzato ”Roma”, 125m, con un volume di 34.000m3 e poteva sollevare sino a 19 tonnellate di peso, fu venduto negli Stati Uniti dove desto molta impressione. Nel 1923 Nobile progettò da solo l’N-1, un’aeronave di tipo semirigido, lunga 107m con un volume di 18.500m3, fu acquistato dalla Norvegia (compì la prima trasvolata della calotta polare). |
La US Navy aveva in servizio due
aeronavi, la USS Akron e la USS Macron ;quest’ultima aveva una velocità massima di
135 km/h e poteva portare quattro caccia monoposto Curtiss Sparrowhawk, che potevano
essere sganciati e recuperati in volo.
Con gli anni trenta i dirigibili iniziarono il loro declino, superati dagli aerei nella
velocità, robustezza, capacità di trasporto e affidabilità.
L’avvento di nuove tecnologie ha portato alla ribalta questi velivoli negli anni
novanta.
Stabilito che per scopi turistici, di sorveglianza, pubblicità, riprese e sollevamento di
carichi ingombranti il dirigibile è ancora oggi un mezzo valido, e grazie
all’ausilio del computer, i nuovi dirigibili risolvono il primario problema della
sicurezza in decollo e atterraggio.
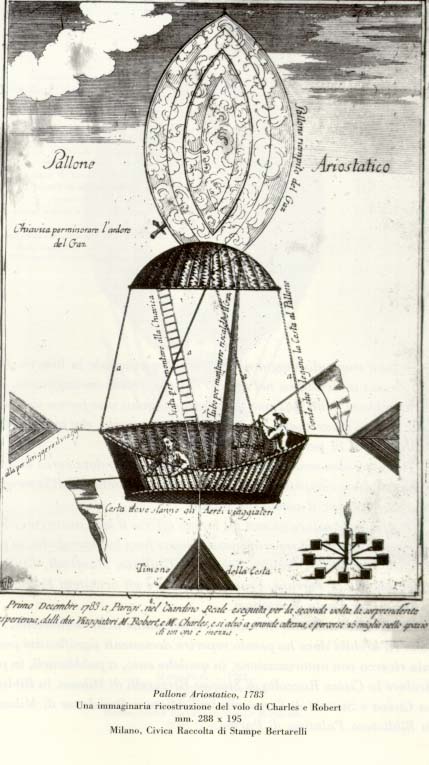 |
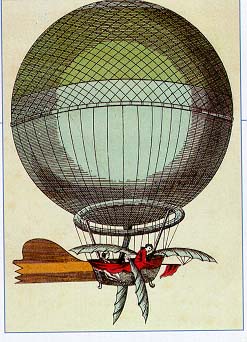 Volo di Blanchard 1785 |
Alla fine dell’Ottocento il sogno dell’uomo di volare si era in qualche modo realizzato, grazie a palloni e dirigibili ma in realtà non era questo il volo che accendeva la passione dei pionieri: quello che si voleva era volare su mezzi controllabili, dotati di ali e motore. Gli studi sui libratori e le più moderne invenzioni furono utilissimi a questo fine, come il motore a scoppio.
| I primi a realizzare un aereo manovrabile furono i fratelli americani Wilbur (1867) e Orville (1871) Wright. Figli di un pastore protestante, già da piccoli si mostrarono interessati al mondo della meccanica e del volo che coltivarono anche dopo aver aperto un’officina per la riparazione di biciclette. Dopo vari esperimenti con libratori e una specie di galleria del vento artigianale, iniziarono a progettare un velivolo a motore che avrebbero battezzato Flyer. Questo aveva un motore a scoppio procurato dal meccanico Charles Taylor, montato in posizione centrale e accoppiato a due eliche controrotanti, in modo che si annullassero a vicenda. | 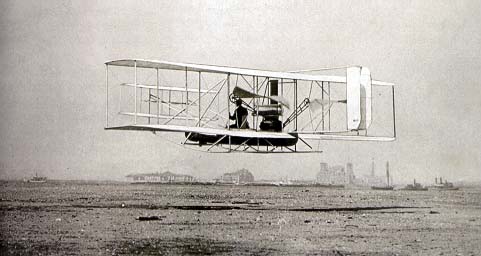 Flyer versione anfibia |
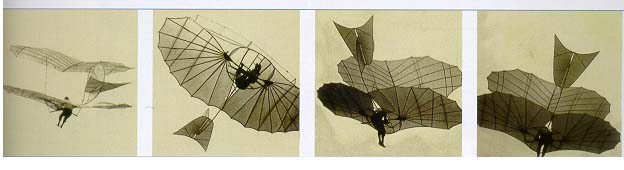 L ibratore biplano 1895 |
Il primo volo non andò a buon fine: subito dopo il decollo il Flyer, dotato di pattini, s’inclinò e ricadde al suolo. Già tre giorni dopo l’esperimento fu ripetuto e questa volta il velivolo rimase in volo per 12 secondi, percorrendo 36 metri, era il 17 Dicembre 1903. Al primo modello ne seguirono altri, tra cui il Flyer III che fu in grado di volare per 40 minuti. |
| Negli anni seguenti i fratelli furono occupati in un tour europeo per presentare la loro creazione, dopo il successo di questo, fondarono a Pau la prima scuola di pilotaggio del mondo. Fu loro anche il primo aereo militare del mondo: il Flyer Model A. Dopo la morte del fratello avvenuta nel 1912, Orville ridusse gradualmente la sua attività arrivando a vendere il suo pacchetto azionario di maggioranza, dedicandosi unicamente alla ricerca sino alla propria morte, nel 1948. | 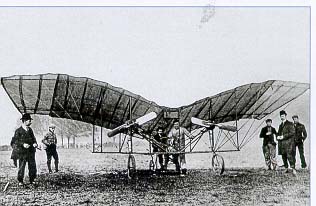 Monoplano Pean bimotore |
 Velivolo ovale a sette ali 1902 |
Il successo dei fratelli Wright ridiede slancio alla sperimentazione aeronautica europea. Fu il brasiliano di origini francesi Alberto Santos Dumont l’autore del primo volo a motore controllato in Europa, con il suo velivolo “14 bis”. Con lo stesso apparecchio vinse la gara organizzata dall’Aero Club di Francia volta a premiare il primo volo superiore a cento metri, egli in 21 secondi ne percorse oltre duecento senza usufruire di alcun sistema di lancio. |
| Un’altra figura
dell’età pionieristica fu il francese Louis Blériot, nato nel 1872, che studiò
ingegneria e si garantì la sicurezza economica fondando un’officina di fari per
automobile. Il primo velivolo che costruì fu un ornitottero ad ali battenti come quello
progettato da Leonardo, ma che si dimostrò un fiasco totale. Il primo progetto ad avere
successo fu realizzato dal suo capofficina Louis Peyret: il Blériot VI. Questo fu in grado di raggiungere gli 80 km/h e la quota, allora eccezionale, di 25 metri. I suoi voli però terminavano spesso con incidenti, tanto che fu soprannominato “l’uomo che cade sempre”; questi insuccessi lo stavano portando ad esaurire le sue risorse economiche, così puntò sulla sua ultima realizzazione: il Blériot XI, un monoplano con motore in posizione anteriore e elica traente. Con questo partecipò alla gara indetta dal quotidiano inglese Daily Mail che avrebbe premiato chi avesse attraversato la Manica in aereo. |
 Voisin |
Con i soldi ricavati dalla vincita
riuscì momentaneamente ad evitare il fallimento delle sue imprese, che dovette però
chiudere definitivamente negli anni Trenta per crisi finanziaria.
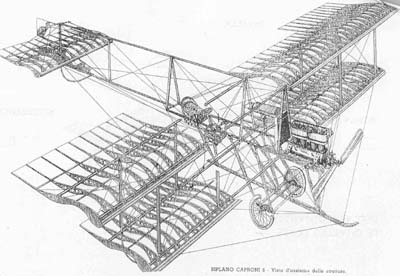 |
Anche l’Italia ebbe i suoi pionieri tra cui spicca Gianni Caproni, fondatore di una ditta che avrebbe assunto un’importanza mondiale. Nacque a Massone d’Arco, nei pressi di Trento, nel 1886; si laureò in ingegneria e s’interessò subito al volo, progettando e costruendo il suo primo velivolo: il Ca.1, che completò nonostante parecchie difficoltà economiche ma che non ebbe fortuna. Diede vita alla società Caproni – De Agostani che produsse il Cm.1, monoplano funzionante. Ebbe però inizio per Caproni un periodo non molto felice: sciolse la società e ne creò altre che pure fallirono, a causa della mancata acquisizione dei velivoli da parte dell’esercito. |
Vendette così le officine e si dedicò alla progettazione, destando interesse nel mondo militare. Iniziò così un periodo florido per la nuova società appena fondata, successo che sarebbe continuato sino al 1945 con la realizzazione di 170 progetti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale tentò, senza grande successo, di convertire la sua industria producendo autoveicoli, quindi morì a Roma nel 1957. A lui è dedicato il museo dell’aeronautica e l’aeroporto di Trento.
| E' stato ricordato anche da D'annunzio, il quale volò sui suoi aerei, lasciando per iscritto l'ammirazione per il suo operato | .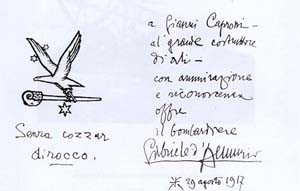 |
 Manifesto del 1915 |
Ad appena una decina d’anni dall’inizio della sua storia, l’aviazione doveva già fronteggiare un grosso problema: la Grande Guerra. Gli aerei del 1913 possedevano già tutti gli elementi caratteristici di sempre: un motore a scoppio accoppiato ad un’elica, due o più ali per la portanza, superfici di coda stabilizzanti, superfici mobili di controllo e una fusoliera in grado di ospitare l’equipaggio. Di lì a poco l’aviazione avrebbe compiuto un progresso davvero eccezionale: prima del 1914 l’aereo a motore era già stato impiegato nelle imprese belliche, le quali, però, erano perlopiù azioni isolate. Ma l’idea dell’aereo come arma di guerra era già nell’aria: Giulio Douchet e Bertram Dickson li ipotizzavano come futuri caccia e bombardieri. Di lì a pochi anni la storia avrebbe dato loro ragione.All’inizio del conflitto i velivoli in servizio erano semplici derivati dei modelli sportivi e non possedevano alcun tipo di armamento. |
Francia e Gran Bretagna ne schieravano
diversi tipi come i Bleriot XI, i Farman MF.7 e MF.11 e i Caudron G.3. Dal canto loro
anche i tedeschi disponevano di quasi 250 aerei tra cui i biplani Aviatik B.I/II, Albatros
B.II, e monoplani Taube LE-3. Nessuna nazione però ne aveva pianificato l’uso in
guerra: i primi tentativi furono, così, isolati e individuali.
I primi scontri aerei si condussero con normali fucili da caccia, carabine e pistole,
tanto che sembravano più duelli a cavallo che non azioni belliche.
| All’inizio ognuno si arrangiava come poteva: c’era chi andava addosso al nemico provocando la perdita della propria vita, oltre che dell’aereo; altri lanciavano granate a mano oppure attaccavano dei rampini per squarciare le ali nemiche; altri ancora lasciavano penzolare delle funi con la speranza che queste si impigliassero nelle eliche dei nemici. L’introduzione della mitragliatrice in posizione fissa davanti al pilota sembrò segnare la svolta nei conflitti aerei; ma i proiettili dovevano passare attraverso il disco dell’elica con la certezza di segnarne via le pale. |  Velivolo Latham |
La soluzione fu trovata solo nel 1915
quando Morane-Saulnier applicò alle pale dell’elica delle placche di corazzatura per
deviare la traiettoria dei colpi: grazie a quest’idea, Roland Garros fu il primo
pilota ad abbattere un aereo nemico il 1° aprile 1915 con il primo vero velivolo da
caccia, il Morane-Saulnier L.
Il Fokker E.III, tedesco, fu il primo vero caccia moderno e la sua superiorità era dovuta
alla presenza del sincronizzatore, un congegno meccanico sviluppato da Anthony Fokker, che
comandava lo sparo della mitragliatrice e lo interrompeva al passaggio delle pale davanti
alla bocca di fuoco. Un altro punto a favore del “flagello Fokker” (così
chiamato per la sua netta superiorità) consisteva nella maggiore agilità rispetto al
fuoco nemico, permessa dal fatto che il veicolo era monoposto. In risposta a questa
autentica macchina da guerra, gli inglesi, nell’inverno del 1916, sfornarono il RAF
F.E. 2b, un biplano biposto con elica spingente che raggiungeva i 146 Km/h. Anche i
francesi vollero controbattere allo strapotere del Fokker e nell’estate del 1915
costruirono il Nieuport Bebè, un biplano veloce e maneggevole, capostipite di una
fortunata famiglia di caccia; grazie a questo velivolo assi come De Rose, Guynemer, E
Nungesser inflissero gravi perdite ai tedeschi durante la battaglia di Verdun, nel
febbraio 1916.
I tedeschi, però, non si diedero per vinti e riuscirono a riconquistare il terreno
perduto grazie all’Albatros D.II e ad un altro aereo di produzione austriaca,
l’Hansa-Brandeburg D.I. Quest’ultimo, però, presentava gravi problemi di
stabilità e di visibilità e sin dall’inizio diede origine a numerosi incidenti che
gli garantirono l’appellativo di “bara”.
Nell’autunno 1916, arrivò la risposta dei francesi: lo SPAD S.VII, probabilmente il
miglior caccia del primo periodo di guerra, che raggiungeva l’incredibile velocità
di 196 Km/h che lo portava alla salita a 3000 metri in appena 15 minuti. Questo aereo
entrò in servizio il 2 settembre 1916 e incontrò il favore di molti piloti del tempo,
fra cui l’asso italiano Francesco Baracca. Il 4 aprile 1917 volò lo SPAD S.XIII che
superava l’S.VII nelle prestazioni, ma che, a causa della scarsa maneggevolezza, non
fu adottato dai piloti che gli preferirono la precedente versione.
Il 1917 vide l’entrata in campo di altri eccellenti velivoli: i britannici Sopwith
F.I Camel e Triplane e il RAF S.E.5G, il francese Hanriot HD.IG, e i tedeschi, Pfalz
D.III, Albatros D.III e D.V. e Fokker D.I. Quest’ultimo entrò in servizio
nell’agosto del 1917 e fu subito apprezzato per le sue doti di manovrabilità e
velocità in salita: tra gli assi che lo utilizzarono spicca Manfred Von Richtofen¸
passato alla storia con il soprannome di Barone Rosso. Antecedente al Fokker Dr.I fu
l’Albatros D.III, utilizzato dallo stesso Von Richtofen nel 1917, che permise alla
Germania di riconquistare la superiorità aerea sul campo di battaglia. Il D.III
presentava, però, un difetto: nelle picchiate prolungate tendeva a perdere l’ala
inferiore. Questo problema fu risolto impiegando ali più robuste, installate
sull’evoluzione del D.III, il D.V.
Quando le sorti del conflitto erano ancora in bilico e quando apparve evidente la
sconfitta, la Germania fu in grado di realizzare alcuni dei suoi migliori caccia, come il
Siemens-Schuckert D.III/IV e il Fokker D.VII che forse fu il miglior aereo da
combattimento della Grande Guerra.
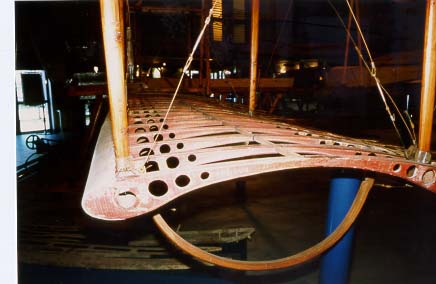 Museo Caproni di Trento. Struttua di un'ala di un modello progettato dall'ing. Caproni dove si evidenzia la struttuta a centine e a longheroni. |
Il progresso tecnologico alla
fine della Prima Guerra Mondiale era ormai evidente: i velivoli cominciavano a montare
motori in linea e non più rotativi; nel 1918 apparve lo Junkers D.I, il primo caccia
monoplano di costruzione interamente metallica. Anche i bombardieri avevano fatto passi da gigante: all’inizio del conflitto erano rappresentati da velivoli come il Caudron G.4, il Farman F.40 e il Caproni Ca.32. Negli anni apparvero mezzi molto più grandi e capaci come il Vikers Vimy e l’Handley-Page V/1500. |
La Prima Guerra Mondiale rese l’aereo un mezzo affascinante e leggendario e ne favorì largamente la diffusione. Grazie agli sviluppi tecnologici tutti i velivoli erano ormai molto più affidabili, robusti e controllabili di quattro anni prima e il dopoguerra avrebbe visto il diffondersi dell’aereo anche come mezzo di trasporto. Finita la guerra, il suo sviluppo sarebbe stato assicurato anche dalla sete di avventura e di gloria dei piloti e dei costruttori, che si sarebbe rivolta al campo dei record e delle grandi imprese.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: GLI ALLEATI
Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale non colse affatto il mondo di sorpresa, già
dagli anni Trenta, i venti di guerra solcavano Europa, Africa e Asia dove nazionalismo,
espansionismo e politica di potenza avevano acceso guerre di vario tipo. Alla fine degli
anni Trenta in Europa era in corso una vera e propria corsa agli armamenti che portò
all’apparizione di aerei sempre più moderni e capaci dei loro predecessori. Le
grandi potenze più coinvolte dagli avvenimenti bellici erano Francia e Gran Bretagna,
entrate in guerra a seguito dell’invasione tedesca della Polonia.
Il miglior caccia dell’aeronautica francese fu il Dewotoine D-520, apparso nel 1936:
aveva linee molto moderne e prestazioni d’avanguardia, ma solo un gruppo caccia lo
aveva in dotazione, non poté quindi influenzare i combattimenti. A metà degli anni
Trenta la RAF (Royal Air Force) non era ancora adeguata ai tempi; il processo di riarmo
diede, nel 1933, il via alla produzione dell’Hurricane, un aeroplano estremamente
avanzato per l’epoca. Dopo la sfortunata campagna francese, furono proprio gli
Hurricane a sostenere l’attacco tedesco durante la battaglia d’Inghilterra nel
1940, riuscendo respingere con successo le incursioni di bombardieri e caccia. Già
dall’anno successivo, però, iniziò a dimostrarsi superato, ma proseguì la sua
carriera bellica nel ruolo di cacciabombardiere. Il suo declino non rappresentò un
problema per la RAF che lo aveva già rimpiazzato con il Supermarine Spitfire, uno dei
migliori caccia della storia dell’aviazione.
Era un velivolo slanciato ed elegante, ma anche efficiente e innovativo, lo stesso
armamento dell’Hurricane ma un motore più potente e maggiore manovrabilità.
Un altro importante aereo da combattimento britannico fu l’Hawker Typhoon. Nacque
alla fine degli anni Trenta con problemi al motore a cui se ne aggiunsero altri di tipo
strutturale, tanto che fu vicino dall’essere ritirato dopo alcuni incidenti mortali.
A seguito delle modifiche apportate, si decise di utilizzarlo nel ruolo di
cacciabombardiere, dove si dimostrò subito eccezionale per l’appoggio tattico
offerto agli alleati durante lo sbarco in Normandia.
L’ultimo caccia della RAF fu il Gloster Meteor, se non altro perché fu il primo e
unico caccia alleato a reazione a partecipare alle operazioni belliche: il suo principale
compito era intercettare le bombe volanti tedesche. Gli ultimi impieghi del Meteor
risalgono al 1961, nella guerra di Corea e nelle guerre arabo-israeliane.
La RAF utilizzò nel conflitto anche diversi tipi di bombardieri tra cui l’Avro
Lancaster e il de Havilland Mosquito. Il primo venne utilizzato dal 1942 anche per
contromisure radar, ricognizione e pattugliamento marittimo, rimanendo in servizio sino
agli anni Cinquanta. Era il bombardiere della RAF che poteva portare le bombe più grandi
tra cui una speciale bomba Wallis per la distruzione delle dighe. Queste furono utilizzate
in una delicata missione affidata ad un gruppo appositamente costituito. La missione era
difficile perché di estrema precisione: solo rispettando precisi parametri quali distanza
e quota, le bombe potevano essere efficienti. Nel 1943 partì l’attacco e non fallì:
due delle tre dighe vennero distrutte. Il simbolo della RAF nel conflitto fu il Mosquito,
inizialmente ritenuto troppo avanzato e per tre volte escluso dall’esercito, ma
quando finalmente poté volare nessuno lo mise più in discussione. Era nato come
bombardiere leggero ma grazie alle sue prestazioni e all’economicità di costruzione
(era realizzato in legno), venne utilizzato come ricognitore e caccia notturno.
Anche l’industria statunitense dovette, tra gli anni Trenta e Quaranta, accelerare il
passo per mettersi in pari e superare il livello tecnico dei propri avversari. Con
l’entrata in guerra degli Stati Uniti, avvenuta nel 1941 a causa dell’attacco
giapponese a Pearl Harbor, apparirono due velivoli da caccia: il primo fu il Lockheed P-38
Lightning, un intercettore d’alta quota dalla struttura decisamente innovativa e con
un elevata autonomia. Nell’Europa e nel Nord – Africa si rivelò superiore il
Republic P-47 Thunderbolt, utilizzato dall’Inghilterra come caccia di scorta ai
bombardieri dal 1943. Nonostante le sembianze di velivolo goffo e tozzo, era un caccia
veloce, ben armato e robusto, ottimo sia nei duelli aerei sia come cacciabombardiere.
La potenza aerea americana non si affermò solo con gli aerei da caccia ma anche e
soprattutto con bombardieri pesanti, che più di tutti contribuirono alla vittoria finale
su Germania e Giappone. Il più famoso fu il Boeing B-17 Flying Fortress: allo scoppio
della guerra era l’unico velivolo veramente moderno nelle file americane. Con questo
gli americani misero a punto le tecniche di bombardamento diurno a lungo raggio,
utilizzando le formazioni a scatola. Questa tecnica portò inizialmente alla convinzione
di poter volare senza scorta, soluzione che provocò gravi perdite; le missioni erano
soprattutto effettuate di giorno, in modo da essere più precisi nello sgancio, provocando
perdite sempre alte ma l’efficacia degli attacchi era impressionante.
Il più avanzato dei bombardieri alleati fu il Boeing B-29 Superfortress, datato 1942. Era
un velivolo davvero all’avanguardia, con grandissima autonomia in modo da operare sul
fronte asiatico. La chiave di volta per la rapida fine della guerra fu una campagna di
bombardamenti che culminò con lo sgancio delle due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki
il 6 e 9 agosto 1945, missioni effettuate proprio da B-29.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE: LE POTENZE DELL'ASSE
La rinascita dell’aeronautica militare tedesca era avvenuta lentamente e di nascosto,
a cause delle clausole imposte dall’armistizio di Versailles. La fondazione ufficiale
della Luftwaffe risale al 1° marzo 1935 e da quel momento il riarmo tedesco si fece
pubblico sostenuto. Nel primo periodo di guerra, la Luftwaffe fu la forza aerea più
potente del mondo, sia per qualità sia per numero di mezzi impiegati. L’unico neo
era rappresentato dalla mancanza di bombardieri pesanti, fattore che sarebbe costato molto
caro alla potenza tedesca. La Guerra lampo, iniziata nel ’39, ebbe come simbolo lo
Junkers Ju-87 Stuka, un bombardiere a tuffo, monomotore biposto. Derivato dal
perfezionamento dello Ju-87°, il Ju-87 era un bombardiere di micidiale precisione, ma
già nel 1940 denunciava alcuni limiti, primo fra tutti la necessità di operare in
superiorità aerea, a causa delle sue prestazioni non eccezionali. Ciononostante rimase in
servizio per tutto il conflitto, grazie anche alle sue straordinarie doti di robustezza
che lo resero un temibile velivolo cacciacarri. Proprio con questo si distinse Ulrich
Rudel, il più famoso pilota della Luftwaffe, che durante l’attacco alla corazzata
sovietica Marat sganciò la sua bomba ad appena 300 metri di quota e riuscendo persino a
recuperare l’aereo passando ad appena 3 metri dal pelo dell’acqua.
All’inizio del conflitto, la Luftwaffe schierava anche tre famosi bombardieri: il
Dornier Do-17, lo Heinkel He-III e lo Junkers Ju-88. Il bimotore Dornier vide la luce nel
1934 per soddisfare la richiesta della Lufthansa, che voleva un veloce aereo postale che
potesse anche trasportare sei passeggeri. Tuttavia non si rivelò molto adatto a questi
compiti, ma il suo progetto era valido anche dal punto di vista militare. Stessa origine
aveva avuto l’Heinkel He-III, nato ufficialmente come veicolo commerciale, ma poi
trasformato per il suo vero scopo, il bombardamento: da questo punto di vista, infatti, si
dimostrò terribilmente efficace.
Il miglior bombardiere tedesco fu senz’altro lo Ju-88, un bimotore nato nel 1935, ma
che volò per la prima volta solamente il 21 dicembre 1936. Col passare del tempo fu
sviluppato anche in versioni da caccia, da ricognizione, da attacco antinave, da attacco
anticarro, da bombardamento e persino da bomba volante guidata: questo programma prevedeva
l’installazione di un Bf-109 sul suo dorso; il pilota sedeva nel Messerschmitt e
pilotava la coppia e, una volta giunto sul bersaglio, sganciava lo Ju-88 e volava via con
il caccia. I velivoli che comunque rappresentavano al meglio la Luftwaffe erano
sicuramente i caccia: all’inizio i velivoli più importanti furono il Bf-109 e il
bimotore Bf-110.
Il primo rimane ancora oggi il simbolo della Luftwaffe e, con quasi 35000 esemplari, fu
l’aereo più prodotto della Seconda Guerra Mondiale nonché uno dei caccia più
famosi della storia dell’aviazione. Quest’aereo possedeva il motore più potente
dell’epoca, il Rolls-Royce da 695 Hp, e poco dopo la sua presentazione s’impose
su altri tre concorrenti: l’Arado ar-80, il Focke-Wulf Fw 159 e l’Heinkel
He-112. Di lì a poco sarebbe nata la versione B che avrebbe portato il Bf-109B ad essere
il miglior caccia del mondo. Nel 1940 avrebbe poi incontrato il suo eterno rivale, lo
Spitfire.
La versione più importante del Bf-109 fu la G che presentava un nuovo motore DB-605 da
1800
Hp; il Bf-109 fu l’aereo preferito da assi del calibro di Gerhard Backhorn e di Eric
Hartmann, detentore del record di vittorie: ben 352, la migliore prestazione assoluta. Il
culmine dell’evoluzione sfociò nella versione K-4, che montava un motore da 2000 Hp
e registrava un peso al decollo quasi doppio rispetto al primo prototipo. Non altrettanto
decorosa fu la carriera del Bf-110, un caccia pesante a lungo raggio, che, a causa delle
inferiori doti di accelerazione e manovrabilità, non riusciva a tenere testa ai caccia
inglesi. Nel 1941, perciò, la Luftwaffe cominciò ad utilizzarlo come caccia notturno,
ottenendo i migliori risultati dalla versione G, ma anche come ricognitore e
cacciabombardiere. Assieme al Bf-109, il miglior caccia tedesco fu senz’altro il
Focke-Wulf 190, che per certi aspetti gli era persino superiore; richiesto dalla Luftwaffe
come aereo da affiancare al Messerschmitt, il Focke nacque dall’idea
dell’ingegner Kurt Tank che realizzò un velivolo veloce, ma più pesante e robusto,
quindi meno esasperato di Bf-109 e Spitfire. Riuscì nel suo intento grazie al motore BMW,
un motore che sviluppava ben 1550 Hp. Il Focke si dimostrò subito migliore dello
Spitfire, vantando un pilotaggio piacevole, grande velocità e maneggevolezza.
All’inizio del 1944 apparve l’ultima versione, la D, che montava un nuovo motore
Jumo da 1800 Hp.
Si trattava dei primi aerei operativi a razzo che impressionarono gli alleati, ma che non
incisero nei combattimenti. Il primo di questi fu il Messerschmitt Me.262. I ritardi
furono dovuti soprattutto alle difficoltà di messa a punto dei motori BMW. Il Me.262
aveva,però, un grosso problema: la configurazione del carrello faceva si che in decollo
gli scarichi dei reattori interferissero con l’azione dei timoni di profondità e il
velivolo non riusciva a staccarsi da terra. Lo sviluppo dell’aereo andò a rilento a
causa del volere di Hitler di trasformare il Me.262 in un bombardiere.
Tedesco fu anche il primo bombardiere a reazione della storia: l’Arado 234 Blitz che
entrò in servizio nel 1944, ma che vide solo un limitato impiego bellico nel 1945 come
ricognitore e bombardiere.
Il principale alleato tedesco della Seconda Guerra Mondiale fu l’Italia che, però,
all’inizio del conflitto, presentava come modello di punta il Fiat CR.42 Falco, un
biplano a carrello fisso che alla sua apparizione era già largamente superato. Un anno
prima della presentazione del Falco, aveva volato il Fiat G 50 Freccia che però perse la
sfida contro il Macchi MC 200 per la produzione in serie. Quest’ultimo non fu
comunque un successo. Ben superiore era il Macchi MC 200 Saetta, che vantava ottime
prestazioni e venne costruito in circa 1200 esemplari sino al luglio 1942, quando fu
rimpiazzato dal modello Folgore. Questo non era altro che il Saetta rimotorizzato con un
Mercedes-Benz da 1100 Hp, che lo spingeva a 600 Km/h. la versione finale fu il Macchi MC
205 Veltro, che adottava il nuovo motore Db.605 da 1475 Hp. Il miglior caccia italiano fu,
probabilmente, il Fiat G.55 Centauro, dotato di tre cannoncini da 20 mm e velocità
massima di 630 Km/h. l’ultimo caccia che montò i motori DB 605 fu il Reggiane 2005
Sagittario. Un posto di rilievo nel panorama aeronautico italiano lo ebbe il SIAI
Marchetti S.M. 79 Sparviero, un trimotore a trasporto civile a otto posti, che si
dimostrò subito velocissimo conquistando sei record mondiali.
Soprannominato “il gobbo maledetto”, per via della conformazione della
fusoliera, continuò ad essere utilizzato come trasporto sino agli anni Sessanta.
Dall’altra parte del mondo la terza forza dell’asse, il Giappone, aveva iniziato
il conflitto con un caccia di eccellente livello: il Mitsubishi A6M Zero. Questo aereo
entrò in servizio nel luglio del 1940 e sino al 1942 rimase probabilmente il miglior
caccia del Pacifico per la sue caratteristiche di manovrabilità e velocità, nonostante
la mancanza di corazzatura e serbatoi autosigillanti.
Dopo essere stato rappresentato dai
caccia nella Grande Guerra, il volo assunse principalmente un carattere di tipo civile.
Nell’Europa postbellica, infatti, essendo state distrutte le maggiori vie di
comunicazione ferroviarie, l’aereo cominciò ad essere utilizzato a scopi
commerciali: in Francia, Gran Bretagna e Germania sorsero le prime compagnie e di
conseguenza le prime rotte fra città importanti come gli assi Parigi – Bruxelles e
Parigi – Londra.
Le prime compagnie aeree europee
Paesi Compagnie Poi riunite in
Gran Bretagna Aircraft TransportHandley Page TransportInstone AirlineDaimler Airway
Imperial Airways (1924)
Germania JunkersDeutscher Aero Lloyd Deutsche Luft Hansa Aktiengesellskaft (Luftansa)
(1926)
Francia FarmanAir OrientAéropostale Air France (1933)
Belgio SNETASabena
Italia Linee aeree d’Italia
Olanda KLM
Danimarca Det Danske Luftfartselskab
I primi aerei di linea furono realizzati convertendo i bombardieri in trasporto passeggeri
oppure utilizzando i vecchi monomotori biposto e triposto che presentavano però difetti
come rumori, vibrazioni, sobbalzi e rigide temperature. Tra i più utilizzati
dell’epoca troviamo il Farman F.60, il più importante aereo da trasporto del primo
dopoguerra, l’Airco D. H. 4, il Breguet br. 14, i bombardieri Handley-Page O/10 e
O/11 e il Vickers Vimy.
L’aviazione civile iniziò a diffondersi anche oltre oceano: utilizzata soprattutto
nel servizio postale, vide nel 1920 la nascita delle prime compagnie tra cui la Aeromarine
West Indies Airways che avrebbe permesso alla potenza americana di superare l’Europa
anche in questo settore. Nacquero, tra il 1925 e il 1926, diverse società come la Stout
Air Services, la Florida Airways, la Western Air Express e la Pacific Air Transport che
sorsero dopo il fallimento della Aeromarine.
Anche il costruttore automobilistico Henry Ford si cimentò nell’aeronautica fondando
la Ford Air Transport Services che avrebbe dato vita al Tri-Motor, un monoplano entrato
nella leggenda.
Verso la metà degli anni Trenta apparvero i primi velivoli “moderni” tra cui il
celeberrimo
Boeing 247 che però deficitava nella capienza mentre la capacità produttiva non era
adeguata alla domanda. Gli ingegneri della Douglas vollero realizzare un mezzo in grado di
contrastare e superare il Boeing e che incorporasse tutte le ultime novità tecnologiche:
nacque cosi la famiglia dei DC (Douglas Commercial) che ebbe il suo rappresentante nel
DC-3. Questo aveva un carrello retrattile a funzionamento idraulico, nuove eliche, nuovi
ammortizzatori, apertura alare maggiore e ala più sottile del precedente DC-2; nella
Seconda Guerra Mondiale fu utilizzato anche come caccia sotto il nome di C-47. Questa
guerra portò notevoli cambiamenti grazie alla costruzione di numerosi aeroporti in tutto
il mondo e agli sviluppi tecnici che avevano dato vita ad aerei plurimotori con
straordinarie capacità di autonomia, affidabilità e carico. Nasceva così l’epoca
dei grandi trasporti a pistoni: Douglas DC-7 e Boeing 377 Stratocruiser. Un aereo inglese,
il D.H.106 Comet, ottenne un immediato successo perché fu il primo aereo da trasporto con
motore a reazione. La sua carriera iniziò però a declinare a partire dal 10 gennaio 1954
data in cui il volo Roma-Ciampino s’inabissò. La causa del disastro non venne
identificata così furono apportate 50 modifiche di vario tipo che si rivelarono inutili
poiché gli incidenti si ripeterono. Dopo vari esami emerse il vero problema: la
fusoliera, alleggerita al massimo, si rompeva a partire dall’angolo squadrato dei
finestrini. Nonostante l’adozione di finestrini ovali e altre misure di sicurezza, i
viaggiatori europei erano ormai diffidenti, avvantaggiando così gli americani che
rubarono alla Gran Bretagna la supremazia nell’aviazione commerciale. Così, nel
1954, nacque il Boeing 707: i lavori di progettazione vennero effettuati con il massimo
impegno, per l’alto rischio di fallimento della compagnia, ne risultò pertanto un
aereo sicuro, robusto e con eccellenti caratteristiche per l’epoca. Fu utilizzato
inizialmente a scopo militare e, modificato con allestimento civile, fece apparire
superati tutti i trasporti utilizzati al momento. Suo concorrente fu il DC-8 della Douglas
che sfruttò le esperienze e i difetti del 707, che aveva, infatti, problemi nel viaggiare
a pieno carico.
Mentre in America le grandi compagnie lottavano per la supremazia nel settore del lungo
raggio, in Europa la competizione riguardava le distanze medio–piccole. La creazione
più importante fu il Caravelle spagnolo, caratterizzato da motori situati a poppa che
davano nuovi vantaggi come un’ala più efficiente e maggiore silenziosità in cabina.
Ma ben presto l’America conquistò il primato anche in questo campo.
Nel periodo tra le due guerre mondiali, il velivolo che contribuì maggiormente allo sviluppo e al diffondersi dell’aviazione nel mondo fu l’idrovolante. Il semplice fatto che non necessitasse di particolari strutture di supporto, ma potesse avvalersi di un qualsiasi specchio d’acqua per il decollo e l’atterraggio, lo resero il mezzo ideale per le grandi esplorazioni e il collegamento commerciale tra i continenti.
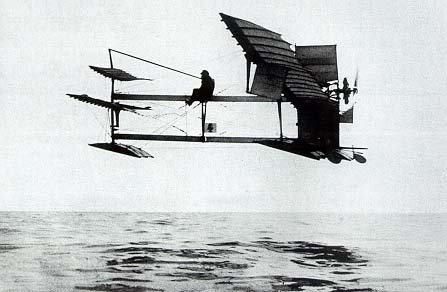 Idrovolante del 1914 |
Il primo idrovolante della
storia fu realizzato dall’ingegnere francese Henri Fabre, nato a Marsiglia nel 1882,
che dopo i primi fallimenti aprì, nel 1910, la via per volare sull’acqua. Già
nell’anno seguente apparvero in Italia, Francia, Belgio e Stati Uniti nuovi
idrovolanti con notevoli progressi. Durante la Prima Guerra Mondiale risultarono utili come mezzi di ricognizione e pattugliamento, dando un ulteriore impulso al progresso aeronautico, tanto che già nel 1919 esistevano aerei terrestri e idrovolanti in grado di superare l’Oceano Atlantico. |
Un’altra grande impresa, il giro
del mondo, fu realizzata da due biplani Douglas World Cruiser (DWC) che percorsero 43.000
km, ma un ufficiale della marina italiana, Francesco De Pinedo, studiò e percorse nel
1925 una rotta di 55.000 km intorno al globo. L’ultima impresa cui prese parte questo
velivolo fu italiana: per dimostrare le capacità tecniche e militari della Regia
Aeronautica, Italo Balbo, nel 1933 organizzò un grandioso raid aereo dall’Italia
agli Stati Uniti e ritorno; il tutto andò a buon fine.
Negli anni Venti e Trenta l’idrovolante venne sfruttato anche come veicolo
commerciale ma durante la Seconda Guerra Mondiale ritornò maggiormente d’uso
militare. Con la fine di questa guerra iniziò il declino degli idroplani: i quadrimotori
terrestri avevano sviluppato maggiore aerodinamica e leggerezza, permettendo voli più
veloci, inoltre le esigenze militari avevano fatto aumentare il numero di aeroporti
costruiti, non vi era perciò il bisogno di velivoli capaci di ammarare. Continuarono
però ad essere utilizzati per usi specifici come il Canadair CL215, anfibio bimotore
antincendio realizzato a metà degli anni Sessanta e, nella sua versione più aggiornata,
ancora in produzione.
I PIONIERI E GLI ASSI DEL CIELO
Manfred Von Richtofen, detto il Barone
Rosso per via del colore che prediligeva per i suoi aerei, è l'eroe indiscusso
dell'aviazione tedesca nella Prima Guerra Mondiale.
Nato a Breslavia (nell'attuale Polonia) nel 1892 da una nobile famiglia, a guerra iniziata
si arruola come pilota.
Inizialmente il suo ruolo è quello di gregario, impegnato in una squadriglia dislocata
sul fronte russo. Qui incontra Oswald Boelke, già famoso come asso incontrastato della
caccia, che ne riconosce immediatamente il talento in volo e lo vuole nella squadriglia
che si accinge a formare.
È in questo ruolo che si compie la carriera gloriosa dell'asso tedesco: abbatte 81 aerei
nemici.
Von Richtofen è sempre fedele alla concezione del combattimento come duello cavalleresco,
in cui entrambi i contendenti rispettano lealmente le regole del gioco.
Diviene comandante di una nuova unità detta il Circo Volante, per via dei colori degli
aerei e per l'estrema rapidità che essi dimostrano nel raggiungere l'obiettivo.
In una delle numerose battaglie ingaggiate insieme con il suo gruppo, il Barone Rosso
trova la morte a soli 26 anni, il 21 aprile 1918. Sopra la valle della Somme una pattuglia
inglese attacca l'aereo del barone e i cinque compagni che lo affiancano. Nella confusione
della lotta l'aereo dell'asso tedesco si abbatte violentemente a terra, rompendo il
carrello: la fusoliera del suo famoso triplano Fokker è intatta, ma il pilota è ormai
morto a causa di un colpo di arma da fuoco. Non è certo su chi ricada la responsabilità
della sua uccisione, anche se l'ipotesi più attendibile è quella che l'attribuisce al
capitano canadese che comandava la pattuglia inglese.
Il giorno dopo gli stessi nemici gli rendono onore con esequie solenni. La Germania è
avvertita della morte dell'eroe tramite un biglietto lanciato da un aereo inglese: è uno
scritto anonimo simile a un bollettino di guerra, ma nel quale si sottolinea che il Barone
è stato seppellito con tutti gli onori militari.
Ufficiale dei lancieri, nel 1912 passò all’aviazione diventando pilota di caccia durante la Prima Guerra Mondiale. Fu considerato un asso per aver abbattuto 34 aerei nemici; abile e coraggioso, cadde colpito da fuoco di fucileria austriaca mentre si era abbassato a volo radente per mitragliare i rincalzi nemici nel corso della battaglia del Piave, il 19 Giugno. I suoi resti, rimasti fra le linee avversarie, furono recuperati cinque giorni dopo la morte.
Le donne cominciarono a volare Il 24
giugno 1784, quando la signora Thible, cantante lirica francese, a Lione su un cono
sferico superò i 2000 m d'altezza.
In Italia Nel 1912 si iscrivono alla scuola Caproni Vizzola Ticino le signorine Rosina
Ferrario, milanese, ed Ester Mieffa, tortonese. Il 3 gennaio 1913 la Ferrario ottiene il
brevetto di pilota: nasce così la prima aviatrice italiana, ottava nel mondo. Elogi ed
incoraggiamenti giungono da ogni parte alla Ferrario.
Dal 22 al 27 aprile, Rosina Ferrario partecipa al Meeting aviatorio di Napoli, il 20
settembre compie voli dimostrativi su Bergamo, il 9 ottobre, in occasione del I Circuito
dei Laghi, vola sino a Como e fa ritorno a Milano in soli 32 minuti ed infine, il 19
novembre, si esibisce nel cielo di Busseto.
Nello stesso anno la diciottenne Ester Mietta (brevettatasi dopo la Ferrario), effettua un
giro propagandistico a Graz e in altri centri austriaci.
Nel 1914, sospesi i voli dell'aviazione civile, la Ferrario deve rinunciare al progettato
volo di propaganda nell'America del Sud e chiede di poter far parte del corpo di volontari
piloti. Ma la domanda non può essere accolta perché "secondo le disposizioni di
legge vigenti non è previsto l'arruolamento di signorine nel Regio Esercito".
| Dopo i primi
tentativi basati su ali battenti, che imitavano gli uccelli, i primi risultati vennero
ottenuti da Otto Lilienthal che compì 2 mila voli con 16 alianti progettati da lui stesso
e proprio durante uno di quei voli si schiantò da un'altezza di 15 metri morendo. Era
l'anno 1896. L'eredità di Lilienthal è stata raccolta dagli odierni appassionati di
paraglider, detto comunemente parapendio, e di deltaplani. La novità sta nelle prestazioni che sono molto differenti tra loro. |
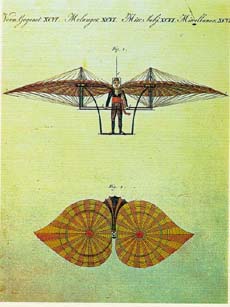 Apparecchio di dengen (clicca l'immagine per ingrandirla) |
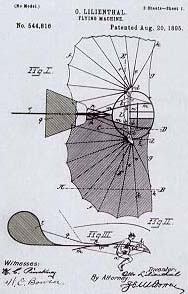 Progetto Lilienthal |
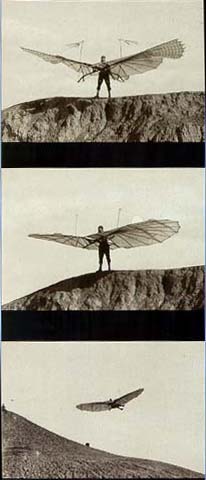 Progetto Lilienthal |
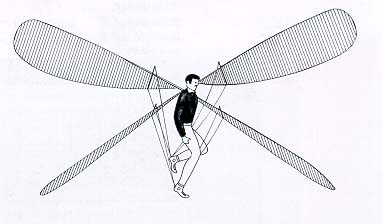 Ornitoptero - 1863 Bourcart |
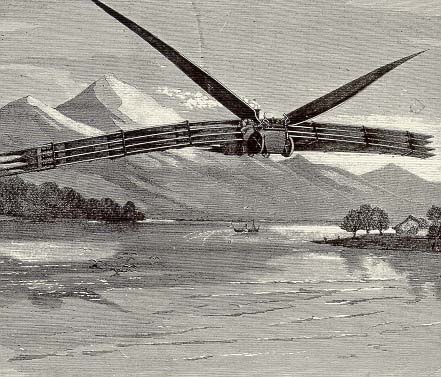 Macchina volante di Kaufman |
Lilienthal usava stecche di
salice che non potevano competere con i moderni tubi di alluminio e nemmeno i tessuti
sintetici utilizzati oggi possono essere paragonati qualitativamente alla tela di cotone
spalmata con il collodio per renderla impermeabile all'aria. Tra gli altri progressi c'è da aggiungere che anche l'aerodinamica ha fatto passi da gigante visto che le forme di ali che si costruiscono oggi a parità di resistenza offrono una forza di sostentamento tripla o quadrupla. In passato il pilota stava in posizione eretta e controllava il volo spostando le gambe, oggi grazie al trapezio e ad un sistema di sospensione si può disporre in maniera da offrire la minima sezione al vento. |
 Viotorius di Sellif |
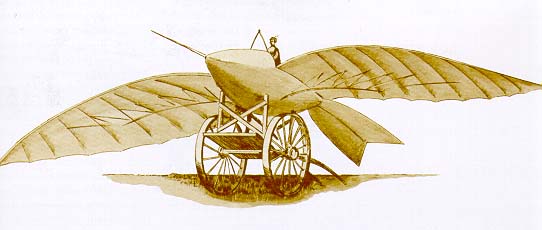 Albatros - Le Bris |
Ma non sempre le strade imboccate dai
progettisti hanno portato a successi o a nuove conquiste. E' il caso dei progetti di
macchine a propulsione umana. Il problema sta nel fatto che un buon atleta non è in grado
di produrre una potenza superiore a o,4 cavalli mentre il più piccolo motore per
ultraleggeri ne produce 10. Questa disparità non ha aiutato i progettisti che tuttavia
non demordono.
Il primo "volo muscolare" è stato realizzato nel 1977 quando Bryan Allen
riuscì a compiere un circuito ad 8 di quasi due chilometri con le sue forze. L'ala di
quell'aereo progettato da Paul McCready aveva un'ala di 30 metri e pesava grazie ai
materiali usati solo 32 kg. Buffi sono i progetti creati di elicotteri a pedali che per
ora non hanno ancora dato risultati efficienti. Questi ibridi tra biciclette ed elicotteri
sono forse destinati a diventare un divertente sport nei prossimi anni, tuttavia l'attuale
rompicapo per ingegneri e designer è tentare di superare la prestazione migliore di 19
secondi di volo ad un'altezza di 20 cm dal suolo. Il progetto che è in fase di attuazione
è quello di Helios, un modello leggerissimo studiato da un gruppo di ingegneri in Canada.
E' formato da una scocca in fibra di carbonio e 2 eliche lunghe 35 m poste una sopra
l'altra sotto l'abitacolo. Il problema è che è difficile che un uomo normale riesca a
muoverlo. Chi tenterà di farlo alzare in volo sarà Francçois Maisonneuve che già da 4
anni si allena per riuscire a volare per più di un minuto. Ma accanto a questo progetto
che forse riuscirà nel suo piccolo intento ci sono veri e propri fallimenti come Papillon
un "biciclottero" ideato dall'università giapponese Nihon che non riuscì
nemmeno a staccarsi da terra.
 Elicottero 1924 |
Il campo nel quale i progressi danno veri risultati sono quelli del volo personale motorizzato. In questo senso i primi tentativi iniziarono negli anni '50. I primi progetti sono stati quelli dei jet pack, zaini a razzo utilizzati in film come 007 e comparsi anche alle Olimpiadi del 1984. Gli sviluppi in questo campo non sono proseguiti vista la scarsa autonomia e l'elevata rumorosità. |
I veri successi furono le piattaforme volanti di Hiller del 1955 che hanno tentato di semplificare il complesso pilotaggio dell'elicottero mettendo il pilota in piedi dentro una specie di balconcino circolare. Novità interessante è SoloTrek una macchina a due eliche pesante circa 200 kg per la cui realizzazione ha collaborato anche la NASA, l'esercito amiricano e la società Millennium Jet. SoloTrek è un macchinario da indossare sulla schiena, provvisto di due eliche alimentate da un motore a benzina. SoloTrek può volare fino a 110 km/h e volare ad un'altezza di 2500 metri con un'autonomia di centinaia di kilometri. SoloTrek possiede la sigla xfv ossia "exo-skeletono flying vehicle" (esoscheletro volante). Ritorna ai due rotori sovrapposti l'Airscooter ultimo tentativo di creare una macchina personale simile all'elicottero, ma semplificato al massimo. Pesa 124 kg e si pilota spostando avanti e indietro o ruotando un manubrio: insomma come una moto. Il problema vero in questo prototipo è di commercializzazione visto che il prezzo oscilla tra i 25 e i 50 mila euro. Sembrerebbe allora che l'unico modo per realizzare il sogno del volo individuale sia quello di ricorrere agli ultraleggeri. In realtà non è detta l'ultima parola. Ci si può chiedere come mai nessuno riesca a pensare a qualcosa di simile ad un'auto, con le stesse funzioni, ma che abbia il vantaggio che possa volare e che si possa parcheggiare nel garage di casa. In realtà alcun ci hanno pensato e hanno sviluppato veri prototipi funzionanti, ma il vero problema non è tecnologico, ma organizzativo: la gestione di un traffico "tridimensionale" in una grande città.
Tutti i problemi
organizzativo-legislativi non hanno fermato Paul Moeller che nel 1999 ha realizzto la
Skycar un'automobile dotata di ventole che la sollevano in aria e la lanciano ad una
velocità di 600km/h. Paul Moeller aveva ipotizzato di riuscire entro il 2003 a
commercializzare la Skycar con un prezzo intorno a 60 mila euo così ha iniziato la
costruzione del prototipo a Davis, in California. Quest'auto volante viaggerà sulle
strade normali ad una velocità di circa 60 km/h, una volta fuori città ruotando i
deflettori delle quattro turbine saranno in grado di sollevarla e di lanciarla in volo.
La Skycar ha una cabina pressurizzata che le permetterebbe di raggiungere i nove mila
metri di quota ed in previsione di un futuro traffico aereo sarà dotata del sistema
anticollisione utilizzato anche dagli aerei di linea. Oltre a questa automobile volante
Rafi Yoeli un cinquantaduenne israeliano ha creato Cityhawk un ibrido tra automobile ed
elicottero che ha appena iniziato i test di collaudo. La principale differenza rispetto
all'americana Skycar è che le ventole sono nascosta nel vano che di solito contiene il
motore. Cityhawk se non presenterà problemi nei test di collaudo sarà sul mercato tra
cinque anni, ma per allora dovranno cambiare molte leggi perché si possa volare
liberamente in città.
Ma il vero sogno che accompagna l'esistenza dell'uomo sarebbe quello di riuscire nell'impresa del volo senza l'ausilio di macchine volanti. Ma quali mutazioni dovrebbero subire l'umanità per poter spiccare il volo? Per librarci in aria come gli uccelli dovremmo come prima cosa avere uno scheletro diverso, infatti attualmente il nostro scheletro ha la funzione di sostenere pesi cospicui, per volare dovrebbe alleggerirsi notevolmente accettando un teschio dalle pareti sottili, ossa cave e gambe meno muscolose e adatte alla corsa che ci dovrebbe permettere il decollo dopo una rincorsa. Braccia e muscoli del torso si dovrebbero irrobustire e si dovrebbero allungare a dismisura. Secondo alcuni studi per sostenere in planata un uomo con un corpo adatto al volo ( peso di circa 40kg ) ad una velocità di 35 km/h occorrerebbe una superficie alare di circa 3,5 metri quadrati. In fine occorrerebbe una membrana simile a quella dei pipistrelli tesa tra le braccia e il torso, con un'apertura di circa 5 metri ed un osso sternale sporgente più di mezzo metro dalla gabbia toracica attuale.
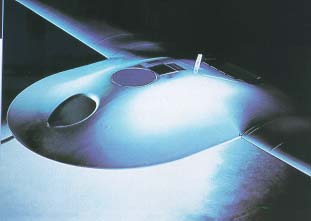 Lockheed |
Il desiderio di volare risale
alla notte dei tempi e proprio quest'anno si celebra il centenario del primo volo di un
aereo avvenuto con i fratelli Wright nel 1903 .Dopo cento anni da quel primo volo sono stati realizzati molti progetti ed ogni giorno nascono nuove prospettive per quel sogno che è antico quanto l'uomo, così che si parli di ultraleggeri, deltaplani, aerei o automobili volanti, l'obbiettivo è sempre uguale: assaporare la libertà del volo dimenticando inquinamento, ingorghi e riuscire a guardare il mondo da un diverso punto di osservazione. |
| La strada non è comunque semplice, anzi sarebbe più corretto affermare che le strade non sono semplici, perché ogni giorno gli ingegneri cercano di trovare la giusta via per poter realizzare finalmente questo bisogno di dominare il cielo che accompagna l'uomo da secoli. | 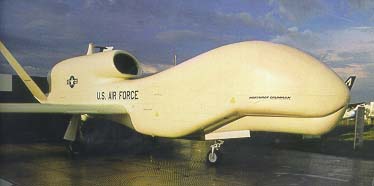 Velivolo senza pilota UAV. |