Regno della libertà e regno
della necessità:
due diversi significati della libertà
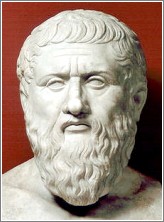 Platone,
nel Mito di Protagora, ci fa vedere che la costituzione della comunità è per
l’uomo motivo di salvezza: l’uscita da una condizione puramente naturale
permette alla specie umana di sopravvivere, trovando quella forza che solo
collettivamente diventa garanzia di vita.
Platone,
nel Mito di Protagora, ci fa vedere che la costituzione della comunità è per
l’uomo motivo di salvezza: l’uscita da una condizione puramente naturale
permette alla specie umana di sopravvivere, trovando quella forza che solo
collettivamente diventa garanzia di vita.
Thomas Hobbes, filosofo inglese del
secolo XVII, ci
spiega che la libertà assoluta di cui l’uomo gode allo stato di natura
non lo preserva certamente da una condizione definita come “miserevole”, segnata
dalla precarietà, dall’instabilità e dalla paura. Anche in questo caso
la ragione naturale indica all’uomo, come via di salvezza, la costituzione
della vita comunitaria, fondata sul rispetto delle regole.
Nel Critone,
Socrate incontra le
Leggi che gli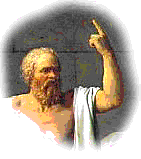 ricordano l’importanza del rispetto loro dovuto da chi vive all’interno di
una comunità. Le Leggi generano, allevano ed educano l’uomo. Senza la loro
presenza non c'è possibilità di armonia e di ordine nell’universo umano, che
finisce per allontanarsi dal modello dell’ordine naturale delle cose.
ricordano l’importanza del rispetto loro dovuto da chi vive all’interno di
una comunità. Le Leggi generano, allevano ed educano l’uomo. Senza la loro
presenza non c'è possibilità di armonia e di ordine nell’universo umano, che
finisce per allontanarsi dal modello dell’ordine naturale delle cose.
Nomos: legge
Armonia: coesistenza tra diversi
Kosmos: universo
Dike: giustizia
Ybris: colpa molto grave
Nato ad Atene nel 470-469 a. C.,
Socrate era figlio di uno scultore - Sofronisco - e di una levatrice - Fenarete - e la sua educazione rispecchiò
lo schema tipico della piccola borghesia a lui
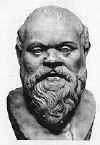 contemporanea: ginnastica e
studio delle opere di poesia. Visse la sua giovinezza in uno dei periodi
intellettualmente più vivaci della storia di Atene, nel momento in cui si
andavano diffondendo le istanze sofistiche e l'insegnamento di Anassagora
ancora svolgeva un ruolo importante. In tarda età sposò Santippe, dalla
quale ebbe tre figli.
contemporanea: ginnastica e
studio delle opere di poesia. Visse la sua giovinezza in uno dei periodi
intellettualmente più vivaci della storia di Atene, nel momento in cui si
andavano diffondendo le istanze sofistiche e l'insegnamento di Anassagora
ancora svolgeva un ruolo importante. In tarda età sposò Santippe, dalla
quale ebbe tre figli.
La vita pubblica di Socrate fu segnata dalla partecipazione alle campagne
militari di Potidea (432-429), Delio (424) e Anfipoli (422) - nelle quali si
distinse per la disciplina e l'equilibrio dimostrati - ma non si volse in
maniera significativa alla pratica politica, se si esclude la carica di
pritano (membro del consiglio con compiti di amministrazione civica)
che gli fu affidata per sorteggio nel 406. Proprio in qualità di pritano,
Socrate difese i comandanti della flotta ateniese che non avevano tratto in
salvo i naufraghi dopo la vittoria di Arginuse e che in seguito furono
condannati con una sentenza irregolare; nel 404 si inimicò il governo in
carica - quello cosiddetto "dei Trenta Tiranni" - per non aver voluto dare
il suo assenzo all'arresto arbitrario di un oppositore politico.
Nel 399, a causa dell'apertura razionalistica del suo pensiero e
dell'influenza che la sua riflessione morale aveva sui giovani aristocratici
ateniesi, la situazione precipitò: fu condannato a morte con l'imputazione
di empietà e di corruzione della gioventù. A portare avanti le accuse -
mosse essenzialmente da motivazioni di ordine politico - furono il poeta
tragico Meleto, l'oratore Licone e il democratico Anito. La presenza di
quest'ultimo dimostra come il regime democratico - restaurato nel 401 a.C.
da Trasibulo - possedesse delle ragioni ben precise per voler condannare
Socrate: innanzitutto, egli intratteneva rapporti personali con figure
eminenti dell'aristocrazia ateniese, quali Crizia e Alcibiade,
particolarmente invise al regime democratico; in secondo luogo, Socrate si
era più volte scagliato contro uno dei pilastri dell'ordinamento democratico
- vale a dire il sorteggio - in quanto ritenuto deleterio ai fini
dell'efficienza del governo cittadino. Non bisogna inoltre dimenticare che
il pensiero di Socrate era in gran parte debitore delle conquiste
intellettuali della sofistica, il cui soggettivismo appariva ai democratici
- e non solo a loro - come un potente fattore disgregante.
Dagli scritti di Platone - uno dei suoi più fedeli discepoli e sicuramente
quello dotato di maggiori potenzialità - possiamo farci un'idea del contegno
di Socrate durante il processo: egli volle difendersi da solo e la sua
arringa autocelebrativa non poté non apparire provocatoria all'organo
giudicante. Il verdetto, come ci si poteva ben aspettare, fu negativo, ma
Socrate accettò serenamente la condanna a morte e rifiutò di aderire al
piano di fuga che i suoi amici avevano preparato per lui.
Egli volle così testimoniare il dovere di
obbedire alle leggi dello Stato - anche se ingiustamente applicate - e bevve
la cicuta dopo aver discusso coi suoi discepoli sul problema
dell'immortalità dell'anima.
Socrate non ha lasciato nulla di scritto: ciò che sappiamo di lui e del suo
pensiero lo dobbiamo alle opere di Platone e ai diversi ritratti - non tutti
positivi - che ne fecero autori come Aristofane, Senofonte e Aristotele.
Una delle peculiarità del pensiero socratico - che in seguito verrà
elaborata da Platone - è data dal dialogo, inteso come strumento
conoscitivo in grado di costruire una verità intersoggettiva attraverso lo
scambio di opinioni con più interlocutori. In tal modo l'identificazione
della verità non avviene più tramite la "scoperta" di un quid
ontologicamente fondato, ma attraverso una metodologia che assume i tratti
di una gnoseologia e che mira alla determinazione di un criterio
interpersonale del sapere. Alla base di tale pratica conoscitiva Socrate
pone l'ignoranza, ovvero la consapevolezza dei propri limiti, del
"sapere di non sapere".
Il primo momento del dialogo socratico viene detto protrettico ed
ha lo scopo di minare le certezze dell'interlocutore attraverso un uso
mirato dell'ironia, della dissimulazione e dell'ostentazione di
un'apparente ingenuità. Il secondo momento è dato dall'imbarazzo -
aporìa - a cui perviene l'interlocutore quando scopre le
conseguenze dalla tesi che ha scelto di sostenere. Una volta avvenuto ciò,
l'intelocutore sarà costretto a sviluppare delle teorie personali: proprio
per questo Socrate definirà la sua tecnica dialogica come maieutica,
in quanto causa della nascita di nuove idee.
Una delle costanti presenti nel dialogo socratico è data dalla domanda: "che
cos'è?". Una tale richiesta rende possibile la determinazione di ciò che
Aristotele chiamerà l'essenza delle cose, o anche il loro
concetto: da un certo numero di singoli uomini, ad esempio, si può
arrivare a stabilire intepersonalmente che cos'è l'uomo.
Altro punto fondamentale del pensiero socratico sta nell'identificazione tra
sapere e virtù, da cui discende la convinzione dell'insegnabilità
della virtù. Quest'ultima, infatti, può essere definita come una scienza
del bene e del male, ed ha la stessa possibilità di essere insegnata di
qualunque altra disciplina: nel momento in cui si conosce la differenza tra
bene e male, è impossibile agire non in conformità con la virtù. Tale
affermazione sta alla base dell'intellettualismo etico di Socrate,
in quanto sottende il primato della conoscenza sulla volontà, eludendo
qualsiasi componente emotiva.
Dal concetto socratico del bene traspare una concezione interiorizzata
dell'uomo, le cui peculiarità risultano orientate verso la sua anima,
considerata come la vera realtà umana, nei confronti della quale il corpo
svolge una mera funzione strumentale. Il motto "conosci te stesso", quindi,
viene da Socrate inteso come un'esortazione a riconoscere nell'anima la vera
realtà dell'uomo e nella virtù il suo compimento.