« Gli uomini, quando parlano generalmente, s’intendono »
Un progetto ideologico di città
La possibilità della costituzione di un’armonia tra gli uomini è legata alla possibilità di costituire un comune terreno del conoscere e dell’agire.
- Socrate e Platone legano la loro ricerca filosofica al piano di rifondazione etico-politica di Atene.
- Platone, nella Lettera Settima, ricorda la sua giovanile propensione per l’attività politica, poi troncata dalla tragica morte del maestro.
- Platone è filosofo delle idee o filosofo della città?
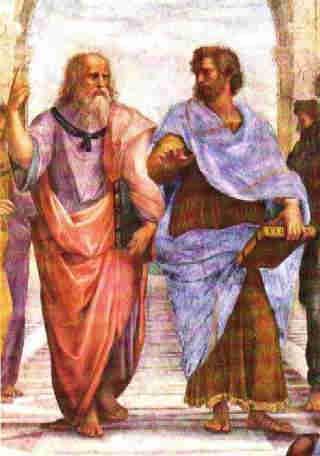
Il progetto politico di Platone: la Dike e le sue degenerazioni
|
|
L’origine dello stato |
||||||||||
|
|
L’ordine dello Stato |
||||||||||
|
|
Le degenerazioni dello Stato:
|
L’ordine è sempre una minaccia per la libertà dell’uomo? Il filosofo olandese Spinoza nel secolo XVII, nel suo Trattato Teologico-Politico, delinea un modello di stato democratico, rispettoso della libertà di coscienza e di espressione dei suoi cittadini, nel quale l’ordine è coerente, appunto, con la libertà di ciascuno.
Sempre nello stesso testo, il filosofo conduce una critica alla credenza superstiziosa nei miracoli; questa spinge gli uomini, in ambito politico, a sottostare ad un potere che si muove violando le regole e che domina sugli uomini con arbitrarietà
Motivi di discussione.
a) Perché è necessaria la legge? Possiamo parlare di una natura umana?
b) Cosa rende potente la legge? (Dio - trad.storica -il più forte..)
c) Il relativismo storico-culturale rende meno efficaci le leggi?
d) La responsabilità è garanzia di un positivo rapporto tra libertà e rispetto delle regole?
Platone: La filosofia al potere
.[ ] Esperite le possibilità dei dialoghi, dalla drammaticità patetica dell’ Apologia di Socrate alla politica antiretorica del Gorgia, il Platone della maturità inventa un ulteriore genere letterario, la lettera filosofica, puro desiderio di dialogo in prima persona con un interlocutore lontano. È un ritorno alla ragione prima della scrittura stessa, nata per inviare messaggi oltre le barriere del tempo e dello spazio, ma usata sotto forma di lettera fino a quel momento soltanto per contenuti pratici. Platone per primo comprende che tutta la letteratura è una grande lettera, un messaggio ai contemporanei e ai posteri, se vorranno leggere, un bel rischio affidato all’incertezza di non arrivare mai alla ragione e al cuore del destinatario.
 Perciò scrive,
presumibilmente attorno al 353 a.C., una lettera - la settima della raccolta
tramandata dal corpus degli scritti platonici - che non chiede una risposta,
ma narra la svolta decisiva della sua vita: il tentativo di portare la
propria filosofia al potere nella Siracusa del tiranno Dionisio II, fallito
per l’irrimediabile corruzione morale del tiranno; l’amicizia con Dione, che
muore mentre cerca di realizzare questo progetto con la forza delle armi; le
ragioni ultime del vivere filosofico. È un testamento spirituale, sospeso
tra le speranze deluse di salvare l’ideale ellenico della libertà e la
consolazione, conoscitiva e contemplativa, del Sommo Bene, che si trasmette
soltanto per esperienza, perché è impossibile da scrivere. La Lettera
settima è impreziosita da alcune tra le più belle riflessioni del
maggior discepolo di Socrate: «La tirannide non è un bene né per chi la
esercita, né per chi la subisce»; «è un male meno grave subire... le grandi
ingiustizie, piuttosto che commetterle»; «nessuna città è felice, e nessun
omo, se non vivono secondo saggezza ispirata da giustizia, sia che le
abbiano in sé come virtù, sia che le abbiano apprese attraverso la giusta
educazione ricevuta da uomini retti»; «nelle guerre civili non c’è tregua al
male fino a che i vincitori, cessando di vendicarsi dei loro avversari, non
metteranno fine a esili stragi e rappresaglie e torneranno padroni di sé
stessi, stabilendo leggi uguali per tutti, vantaggiose tanto per i
vincitori, quanto per i vinti». Quest’ultima massima torna di stringente
attualità nel nostro tempo, quando la globalizzazione economico-culturale ha
reso ogni guerra, dal conflitto mondiale allo scontro locale, una guerra
civile.
Perciò scrive,
presumibilmente attorno al 353 a.C., una lettera - la settima della raccolta
tramandata dal corpus degli scritti platonici - che non chiede una risposta,
ma narra la svolta decisiva della sua vita: il tentativo di portare la
propria filosofia al potere nella Siracusa del tiranno Dionisio II, fallito
per l’irrimediabile corruzione morale del tiranno; l’amicizia con Dione, che
muore mentre cerca di realizzare questo progetto con la forza delle armi; le
ragioni ultime del vivere filosofico. È un testamento spirituale, sospeso
tra le speranze deluse di salvare l’ideale ellenico della libertà e la
consolazione, conoscitiva e contemplativa, del Sommo Bene, che si trasmette
soltanto per esperienza, perché è impossibile da scrivere. La Lettera
settima è impreziosita da alcune tra le più belle riflessioni del
maggior discepolo di Socrate: «La tirannide non è un bene né per chi la
esercita, né per chi la subisce»; «è un male meno grave subire... le grandi
ingiustizie, piuttosto che commetterle»; «nessuna città è felice, e nessun
omo, se non vivono secondo saggezza ispirata da giustizia, sia che le
abbiano in sé come virtù, sia che le abbiano apprese attraverso la giusta
educazione ricevuta da uomini retti»; «nelle guerre civili non c’è tregua al
male fino a che i vincitori, cessando di vendicarsi dei loro avversari, non
metteranno fine a esili stragi e rappresaglie e torneranno padroni di sé
stessi, stabilendo leggi uguali per tutti, vantaggiose tanto per i
vincitori, quanto per i vinti». Quest’ultima massima torna di stringente
attualità nel nostro tempo, quando la globalizzazione economico-culturale ha
reso ogni guerra, dal conflitto mondiale allo scontro locale, una guerra
civile.http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/030204b.htm
Il Trattatto Teologico-Politico
Spinoza: Democrazia e libertà
La assoluta sovranità dello stato al suo interno, è data dalla identificazione della libertà e del potere nella democrazia di Spinoza, e porta alla realizzazione di quella "pace e sicurezza di vita" che, con la libertà, è il fine dello Stato. Poiché la democrazia, come forma di governo, si realizza con decisioni collettive, che sono il risultato delle scelte dei singoli individui che formano il popolo, e che danno luogo alla "maggioranza che decide", la libertà è intrinseca alla sua struttura, alla formazione del potere effettivo, che per essere il risultato della concordia dei cittadini o di una loro maggioranza che si esprime con libera decisione, non può essere contraddittorio o coercitivo nei confronti della libertà, ma si identifica con il suo esercizio. Il contrasto tra potere e libertà che è proprio a tutti i regimi politici nei quali il popolo (cioè la totalità dei cittadini) non si identifica con lo Stato, e che dà luogo a un conflitto permanente fra le istituzioni dello Stato e gli individui, non ha luogo nella democrazia: in questa è la libertà collettiva, identificata nella maggioranza, a prevalere sulla libertà dell’individuo. Ma questa libertà collettiva, espressa nelle leggi, è figlia della ragione che sola dà agli uomini il comune denominatore al quale riportare le loro passioni e la loro individualità. Essa si identifica con l’atto di fondazione della società, e quindi dello Stato e del governo, è fattore costitutivo del potere e quindi della sovranità (o diritto) che a esso è legato. "Nel governo democratico... gli uomini, non potendo tutti pensare nello stesso modo, hanno ammesso che ha forza di legge la decisione che riunisce il maggior numero di suffragi, mantenendo frattanto il potere di abrogare queste leggi, in favore di leggi che loro possono sembrare migliori". Così la teoria democratica di Spinoza unifica potere e libertà, ponendo l’uomo nelle condizioni ottime di realizzazione della propria natura; il "conatus sese conservandi" si forma gli strumenti adatti a esprimere la tensione aspra e difficile verso la totalità dell’essere. La libertà dell’uomo (che è nell’essere causa adeguata del proprio destino) posta a fondamento del governo democratico, porta questo governo a essere regime di pace e sicurezza. In nota al suo ragionamento sui fondamenti della democrazia, nel capitolo XVI del Trattato teologico - politico, Spinoza scrive: "In qualsiasi paese viva, l’uomo aspira alla possibilità di essere libero. In effetti non è egli libero realmente nella misura in cui egli prende la propria ragione per guida? Ma se egli ascolta i consigli della ragione soprattutto desidererà vedere regnare la pace. E la pace civile ha per condizione il rigoroso rispetto della legislazione nazionale. Ne risulta che più l’uomo si lascia guidare dalla Ragione, cioè più è libero, più egli si applica fedelmente a osservare le leggi, cos& igrave; come a eseguire gli ordini dei poteri sovrani del suo paese".
Note biografiche
Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 nov. 1632 - L'Aia, 21 feb. 1677) fu
indubbiamente una delle menti filosofiche più brillanti di tutti i tempi.
 Un
modo estremamente anticonformistico di concepire la filosofia e i suoi
problemi: è questo ciò che differenzia Spinoza da altri autori del
Seicento, pesantemente condizionati dalla condivisione di una tavola
valoriale già acquisita. L'originalità di Spinoza consiste nel rinnovare
la tradizione giudaico-cristiana secondo coerenza, razionalità,
indipendenza di giudizio. Ebreo-olandese, nato in una famiglia sefardita
originaria del Portogallo, Spinoza compì gli studi ad Amsterdam, in
istituti d'istruzione ebraica. La sua formazione, in gran parte
autodidatta, fu piuttosto eclettica, includendo autori classici, come
Cicerone e Seneca, Scolastici e contemporanei: Bacone, Cartesio, Hobbes.
Un
modo estremamente anticonformistico di concepire la filosofia e i suoi
problemi: è questo ciò che differenzia Spinoza da altri autori del
Seicento, pesantemente condizionati dalla condivisione di una tavola
valoriale già acquisita. L'originalità di Spinoza consiste nel rinnovare
la tradizione giudaico-cristiana secondo coerenza, razionalità,
indipendenza di giudizio. Ebreo-olandese, nato in una famiglia sefardita
originaria del Portogallo, Spinoza compì gli studi ad Amsterdam, in
istituti d'istruzione ebraica. La sua formazione, in gran parte
autodidatta, fu piuttosto eclettica, includendo autori classici, come
Cicerone e Seneca, Scolastici e contemporanei: Bacone, Cartesio, Hobbes.
Per una interpretazione eterodossa delle Scritture nel 1656 fu bandito
dalla Sinagoga. Da allora si stabilì in un villaggio dalle parti di Leida,
guadagnandosi da vivere come pulitore di lenti per occhiali e
apparecchiature scientifiche (cannocchiali e microscopi).
Nel 1660 scrive Breve trattato su Dio, l'uomo e la sua felicità. Nello
stesso periodo concepisce l'Etica ( Ethica, more geometrico demonstrata)
opera di grande respiro alla quale lavorò per tutta la vita, e il
Tractatus de intellectus emendatione, una sintesi di storia filosofica
riguardante la gnoseologia e i suoi temi.
Nel 1663 pubblica un commento alla filosofia di Cartesio (Principia
philosophiae) e un abbozzo metafisico, i Cogitata metaphysica. Entra in
contatto con un importante uomo politico, Jan de Witt, capo
dell'opposizione anti-Orangista, il quale concede a Spinoza un assegno
vitalizio.
Nel 1670 esce, anonimamente, il Tractatus theologico-politicus, che attirò
critiche unanimi da parte dei cristiani e degli ex-correligionari di fede
ebraica.
Per Spinoza, la politica è radicata nella teologia, ma quest'ultima, lungi
da essere la dottrina speculativa di un Dio personale, è, in prospettiva
panteistica, lo stesso della dottrina della natura, secondo il celebre
motto Deus sive natura.
