| |
La concezione del
lavoro nel Medioevo |
|
| |
Nell'Alto Medio Evo notiamo un certo
silenzio nei confronti del lavoro e dei lavoratori, silenzio che già
può risultare indicativo di una certa mentalità. Qualche notizia
intorno alla concezione del lavoro, tra V e VIII secolo, la troviamo
nell'ambito delle regole monastiche e nella letteratura agiografica:
spesso emerge, anche se non necessariamente in modo esplicito, un
quesito:

''Un monaco può-deve svolgere un
lavoro manuale?".
Le fonti agiografiche esaltano, spesso,
il valore della vita contemplativa.
Un esempio può essere tratto
dalla biografia di Gregorio Magno il
quale si lamenta, in alcune sue
lettere, di essere stato strappato
alla vita contemplativa per essere gettato nella vita attiva e di
aver dovuto abbandonare Rachele per Lia, Maria per Marta. il
quale si lamenta, in alcune sue
lettere, di essere stato strappato
alla vita contemplativa per essere gettato nella vita attiva e di
aver dovuto abbandonare Rachele per Lia, Maria per Marta.
Più
avanti la riflessione sul lavoro la si ricava da un altro tipo di
documentazione, quale quella dei testi giuridici..., mentre sempre
più sovente la riflessione intorno al lavoro è condotta in relazione
all'idea della società tripartita.
Al di là comunque, delle
fonti cui si può fare riferimento, notiamo che la mentalità comune
medievale si presenta oscillante tra due
atteggiamenti:
Il
disprezzo
del lavoro, inteso come segno di debolezza e di infermità, si lega
indubbiamente al peso che la mentalità barbarica ha avuto sulla
mentalità generale: a questo proposito appare indicativo un passo
tratto dalla Germania di Tacito in cui questo disprezzo del lavoro
accanto all'esaltazione della guerra, emerge in tutta
evidenza: |
|
|
"Nec arare terram aut exspectare annum tam
facile persuaseris quam vocare hostem et vulnera mereri. Pígrum quin
immo et iners videtur, sudore acquirere quod possis sanguine parare.
Quotiens bella non ineunt, non multum in venatibus, plus per otium
transigunt, dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac
bellicosissimus nihil agens.."
(Germania XIV-XV)
|
|
 ''...non [li] convincerai che è più facile arare la terra o attendere il raccolto dell'annata piuttosto che provocare il nemico e guadagnarsi le ferite; anzi sembra loro che sia proprio della gente fiacca e oziosa il procacciarsi con il sudore ciò che si può ottenere con il sangue. Quando non sono in guerra, dedicano molto tempo non alla caccia ma all'ozio, e si dedicano al sonno e al cibo; i più forti e bellicosi non fanno nulla ...'' ''...non [li] convincerai che è più facile arare la terra o attendere il raccolto dell'annata piuttosto che provocare il nemico e guadagnarsi le ferite; anzi sembra loro che sia proprio della gente fiacca e oziosa il procacciarsi con il sudore ciò che si può ottenere con il sangue. Quando non sono in guerra, dedicano molto tempo non alla caccia ma all'ozio, e si dedicano al sonno e al cibo; i più forti e bellicosi non fanno nulla ...''
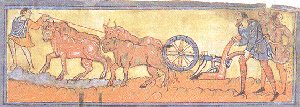
Da questa citazione possiamo ricavare
tutto il disprezzo per il lavoro tipico della società guerriera,
anche se non manca, nelle mitologie germaniche, qualche cenno di
opposta convinzione, quando si fa riferimento al prestigio sociale
degli artigiani metallurgici sacri del mondo
germanico.
Inoltre, salvo alcune eccezioni, la stessa
legislazione barbarica ci appare indicativa del disprezzo per il
lavoro: una scala dei valori sociali e dei loro fondamenti
ideologici colloca i lavoratori all'ultimo posto.
Un
esempio:
presso la legislazione dei Burgundi troviamo la seguente
tabella per quanto concerne la pena relativa all'omicidio: |
|
aratores - porcarii - birbicarii - alii servi
carpentarii
fabri ferraii
aurifices
|
|
30 soldi
40 soldi
50 soldi
150 soldi |
|
| |
Un'ambivalenza simile emerge dal mondo cristiano
medievale; va tenuto presente per prima cosa un fatto: che la
regressione tecnica che ha accompagnato la quasi totale scomparsa
del lavoro specializzato ha determinato l'identificazione tout court
del lavoro con il lavoro manuale e in particolare modo, con il
lavoro rurale.
A questo proposito l'idea della società
tripartita sembra confermare questo disprezzo: Adalberone di Laon, nel sec. XI, rivolgendosi a Roberto il Pio, re di Francia, ricorda
che l'ordine sociale è stato dato da Dio, e che, soprattutto, per
coloro che sono i suoi ministri non è decoroso svolgere nessun tipo
di lavoro. Il lavoro viene dunque identificato con la condizione
servile, mentre alcune associazioni di idee
(laborantes-rustici-illitterati...) producono addirittura una
condanna morale del lavoratore stesso.
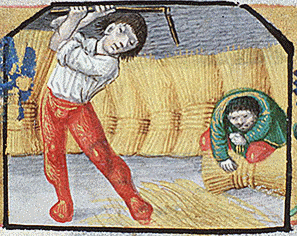 Un'altra fonte utile
per comprendere la concezione del lavoro nel Medioevo può essere lo
studio che M. Mollat ha condotto intorno all'evoluzione semantica
della parola "pauper": questo termine indica in un primo momento il
debole in contrasto con il potente, poi indica colui che nella
povertà assume, in un certo senso, l'"imago Christi", infine colui
che, nell'ordine sociale, si pone come l'escluso, l'emarginato. Se
colleghiamo la condizione della laborator al pauper possono emergere
spunti interessanti: il lavoratore è il debole, che china la testa e
che assume il peso della colpa che grava sull'umanità; poi il
lavoratore è visto come l'umile che rivive umilmente il lavoro
divino della creazione di qualcosa; infine il lavoro è potenza
dell'uomo sul mondo, per cui chi ne è escluso perde la dignità
sociale e, in un certo senso, umana. Un'altra fonte utile
per comprendere la concezione del lavoro nel Medioevo può essere lo
studio che M. Mollat ha condotto intorno all'evoluzione semantica
della parola "pauper": questo termine indica in un primo momento il
debole in contrasto con il potente, poi indica colui che nella
povertà assume, in un certo senso, l'"imago Christi", infine colui
che, nell'ordine sociale, si pone come l'escluso, l'emarginato. Se
colleghiamo la condizione della laborator al pauper possono emergere
spunti interessanti: il lavoratore è il debole, che china la testa e
che assume il peso della colpa che grava sull'umanità; poi il
lavoratore è visto come l'umile che rivive umilmente il lavoro
divino della creazione di qualcosa; infine il lavoro è potenza
dell'uomo sul mondo, per cui chi ne è escluso perde la dignità
sociale e, in un certo senso, umana.
Isole di
valorizzazione del lavoro
Nei secoli dell'Alto Medio Evo,
accanto all'eclissi dei valori del lavoro nei sistemi di valore
sociale, culturale e spirituale, emergono segni di una qualche
valorizzazione del lavoro. Un primo esempio può venire dal lavoro
dei chierici e specialmente del monaco. Si parlava precedentemente,
del quesito relativo al lavoro per i monaci: il Concilio di Orleans
del 511 raccomanda il lavoro manuale ai vescovi, ai preti e lo
impone ai monaci. Il lavoro manuale dunque viene considerato
positivamente, soprattutto se pensiamo al fatto che il monaco,
esemplare per l'umanità tutta, finisce per nobilitarlo; questo ,
anche se va tenuto presente un fatto di non secondaria importanza:
il lavoro del monaco presenta dei caratteri speciali, che quindi
solo in piccola parte possono essere ricondotti al lavoro del
lavoratore qualunque. Per prima cosa la letteratura agiografica ci
conferma che i monaci si dedicavano al lavoro manuale, ma ci fa
capire che non di rado l'attività svolta (magari di costruzione di
macchine...) era più affine alla vita contemplativa nel senso di una
disponibilità di un sapere quasi magico-sovrannaturale. Inoltre
ricordiamo che il senso di questo lavoro monastico è penitenziale.
Proprio perché il lavoro manuale è legato alla caduta, alla
maledizione divina e alla penitenza, i monaci , penitenti per
vocazione, devono dare, in ciò, un chiaro esempio di
mortificazione.
|
|
| |
 |
| |