| |
Tradizionalmente il classicismo si compiace di immaginare gli
antichi Greci come gente che "vive di rendita", che spende cioè la
propria vita nel culto della bellezza e dell'esaltazione della
personalità. (Accanto a questa immagine va però tenuto conto del
fatto che lo sviluppo della vita economica nell'antica Grecia va
collegato con un impulso al guadagno presente presso gli stessi
Greci!).
Un'antica narrazione di carattere mitico dice che la protervia umana
ha spezzato l'incanto dell'età dell'oro , con il suo desiderio di
determinare il proprio destino, portando l'umanità all'età del
ferro, caratterizzata dal lavoro, come evidente segno di decadenza .
Gli dei stessi indirizzano gli uomini alle varie attività (es:
Demetra-agricoltura / Hermese-mercatura / Atena-arti donnesche...).
Esame
del ciclo omerico
 La società narrata da
Omero
è
una società guerriera-cavalleresca che prende sprezzantemente le
distanze dal lavoro, pur con qualche eccezione: infatti l'eroe
omerico combatte anche per il bottino, oltre che per l'onore, cerca
il riscatto dei suoi prigionieri, mentre figure di re in tempo di
pace, non disdegnano di occuparsi della mietitura. La società narrata da
Omero
è
una società guerriera-cavalleresca che prende sprezzantemente le
distanze dal lavoro, pur con qualche eccezione: infatti l'eroe
omerico combatte anche per il bottino, oltre che per l'onore, cerca
il riscatto dei suoi prigionieri, mentre figure di re in tempo di
pace, non disdegnano di occuparsi della mietitura.
Nell'Odissea in particolare, lo spirito commerciale trova una
maggiore attenzione da parte dell'autore: la stessa pirateria non
appare riprovevole (Menelao confessa candidamente di aver accumulato
ricchezze con questo tipo di attività). Sempre nell'Odissea emerge,
da qualche parte, una certa sensibilità nei confronti del basso
popolo e in alcuni casi, degli schiavi. Ma la sproporzione tra
l'eroe e l'uomo in condizione servile resta molte evidente - "Giove
toglie metà del suo valore all'uomo su cui piomba il dì servile".
Il giudizio negativo sul lavoro indica un legame forte tra lavoro e
condizione servile. Ma cosa accade, quali idee emergono quando il
lavoro, diventando esperienza viva, viene pensato come professione
libera? Evidentemente il giudizio muta in un atteggiamento
completamente diverso: è il caso di
Esiodo, che nella vita era un
libero contadino e che, nell'ambito della letteratura greca, viene
spesso considerato come il poeta che per primo sviluppa con forza il
senso della propria individualità. Accanto alla Teogonia (1022
versi, dedicati alla narrazione delle vicende dell' universore e i Giorni" (828 versi), e, in particolare,
il mito di Pandora che spiega la ragione della necessità per cui
l'uomo deve lavorare per vivere, oltre che della presenza dei mali
nel mondo. L'uomo deve lavorare per avere l'abbondanza; questo
dovere non va inteso come una condanna: a differenza degli animali
l'uomo deve evitare l'inganno e la violenza, vivere di onesto lavoro
e rispettare i dettami della natura. Il lavoro è premio a se stesso
e solo grazie ad esso la vita dell'uomo assume senso. Esemplari sono
alcune parole, probabilmente indirizzate al a partire dalla
condizione del Caos originario), va ricordata l'altra grande opera:
"Le opfratello che si crede
troppo in alto per potersi dedicare ad un lavoro manuale: "Nessun
lavoro è vergogna. Poltrire è vergogna".
Siamo a questo punto di fronte a due concezioni di vita opposte,
anche se va aggiunto che la posizione di Esiodo resta un caso
isolato (è difficile trovare un altro che leghi il lavoro al senso
della vita!).
Infatti in generale, la cultura greca segna una netta separazione
tra lavoro e vita emotiva.
A questo proposito vale la pena di ricordare l'uso del termine
 che indica, nello stesso tempo, l'uomo gravato dalla
fatica nel senso fisico del termine, ma anche colui che ha la
coscienza pesante e che dunque è "cattivo". che indica, nello stesso tempo, l'uomo gravato dalla
fatica nel senso fisico del termine, ma anche colui che ha la
coscienza pesante e che dunque è "cattivo".
L'egemonia culturale dell'aristocrazia produce un disprezzo generale
nei confronti del lavoro, disprezzo che trova riscontro in Teognide
che scrive:
Mai non sarà che stia dritta la testa d'un servo, ma sempre
obliqua, il collo torto sempre sarà...
La ricchezza ha corrotto le stirpi...
Interessante è anche l'atteggiamento di
Pindaro
quando usa il termine ponos per indicare la
fatica dell'atleta nel corso delle gare - Teniamo presente che lo
stesso termine indica anche la fatica nel lavoro dei campi: la
differenza di qualità sta nella meta che ci si prefigge. La fatica
legata al lavoro produttivo è spregevole perché non gratuita, e
indicativa di uno stato di dipendenza dell'uomo dalle cose, mentre
l'attività dell'atleta si carica di senso ludico e denota uno
spirito libero e una vita dedicata a coltivare la personalità nel
segno della bellezza.
Il disprezzo per il lavoro non è presente in Grecia solo
nell'ambiente aristocratico (pensiamo a Sparta dove agli Spartiati è
preclusa qualsiasi attività, anche di tipo artigianale) ma anche in
ambiente democratico. E' forte infatti l'idea secondo la quale
l'attività lavorativa compromette l'inserimento dell'individuo nella
vita della comunità, poiché chi è impegnato nella conquista del
sostentamento quotidiano non si può dedicare al perfezionamento
della propria umanità e non è in grado, dunque, di dare un apporto
positivo alla vita della comunità stessa. Platone, che pure ammette
la legittimità del "guadagnarsi da vivere" teme le facili
degenerazioni cui il lavoro può portare, nel senso della brama di
guadagno, e per questo nella Repubblica i guardiani dello Stato non
hanno nulla a che fare con l'attività economica.
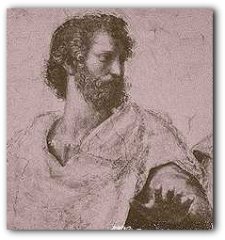 Aristotele,
da parte sua, non condanna la proprietà privata, anzi la vede come
fonte di soddisfazione personale, soprattutto in quanto permette la Aristotele,
da parte sua, non condanna la proprietà privata, anzi la vede come
fonte di soddisfazione personale, soprattutto in quanto permette la
 , cioè la liberalità. Aristotele distingue tra due attività
economiche: l'una, buona, che mira a procacciare i mezzi di
sostentamento per l'uomo libero. L'altra, cattiva, punta al guadagno
in sé e scivola nell'esosità. , cioè la liberalità. Aristotele distingue tra due attività
economiche: l'una, buona, che mira a procacciare i mezzi di
sostentamento per l'uomo libero. L'altra, cattiva, punta al guadagno
in sé e scivola nell'esosità.
L'ozio, d'altra parte, non è il dolce far niente, ma lo spazio nel
quale il cittadino può vivere in un'ottica superiore; il frutto
supremo di questo ozio è l'attività teoretico-scientifica.
C'è comunque un'ottica superiore nella quale pienamente si dà la
migliore condizione per l'uomo e non si tratta certamente del
lavoro. A questo proposito Aristotele è molto chiaro: nell'Etica
Nicomachea egli si chiede cosa sia il vero bene per l'uomo e lo
trova nella felicità, che si presenta nella forma
dell'autosufficienza, della gratuità e del vero piacere e che
consiste nello svolgere la funzione specifica dell'uomo, che la vita
secondo la ragione. Nel libro X dell'Etica Nicomachea la felicità è
legata alla pratica della più alta delle virtù dianoetiche, e cioè
alla sapienza.
Aristotele lega dunque la nobiltà della condizione umana alla vita
teoretica, ed esprime in questo una concezione del lavoro come
attività nettamente subalterna.
Nel mondo greco due
sono
le considerazioni
fondamentali del lavoro:
-
i Greci riconoscono il valore sociale del lavoro e
la sua necessità
-
il lavoro dell'uomo rimanda a qualcosa di più alto
del lavoro prestato (cioè all'attività svolta da libero cittadino
nella comunità umana).
|
|